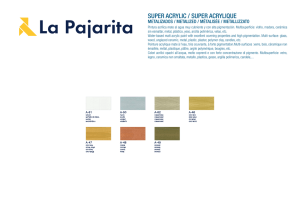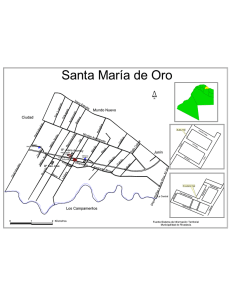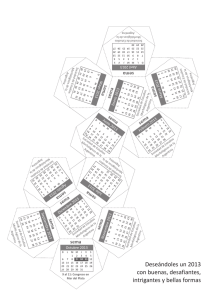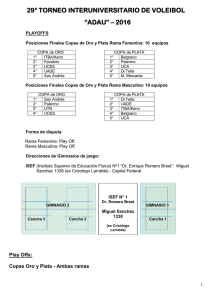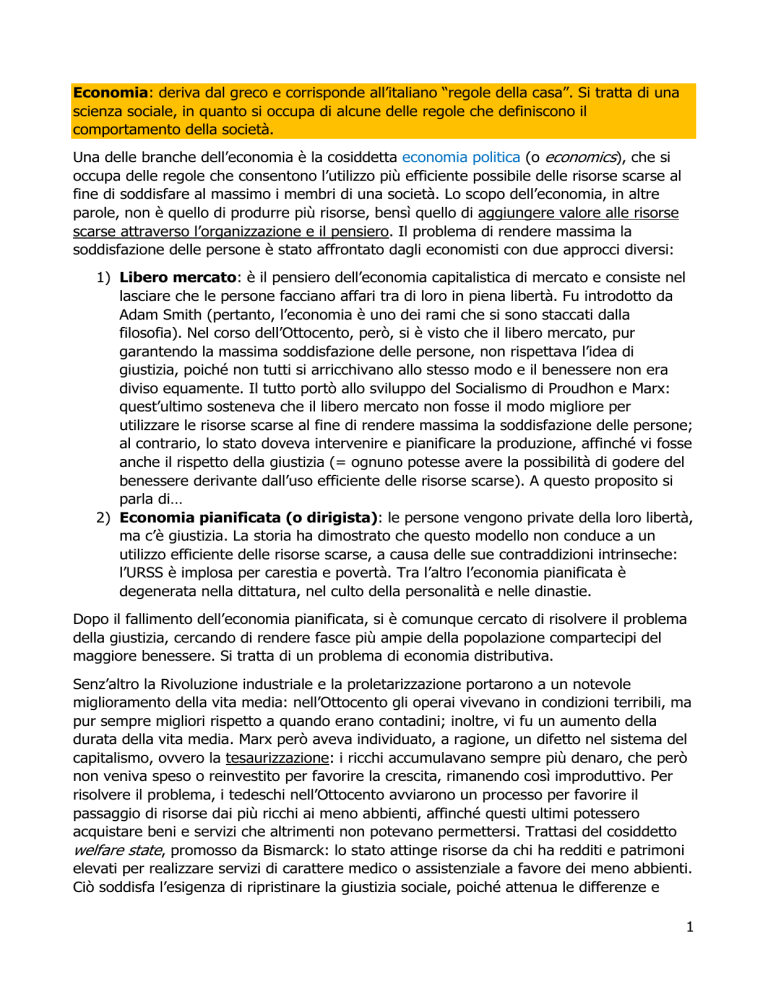
Economia: deriva dal greco e corrisponde all’italiano “regole della casa”. Si tratta di una scienza sociale, in quanto si occupa di alcune delle regole che definiscono il comportamento della società. Una delle branche dell’economia è la cosiddetta economia politica (o economics), che si occupa delle regole che consentono l’utilizzo più efficiente possibile delle risorse scarse al fine di soddisfare al massimo i membri di una società. Lo scopo dell’economia, in altre parole, non è quello di produrre più risorse, bensì quello di aggiungere valore alle risorse scarse attraverso l’organizzazione e il pensiero. Il problema di rendere massima la soddisfazione delle persone è stato affrontato dagli economisti con due approcci diversi: 1) Libero mercato: è il pensiero dell’economia capitalistica di mercato e consiste nel lasciare che le persone facciano affari tra di loro in piena libertà. Fu introdotto da Adam Smith (pertanto, l’economia è uno dei rami che si sono staccati dalla filosofia). Nel corso dell’Ottocento, però, si è visto che il libero mercato, pur garantendo la massima soddisfazione delle persone, non rispettava l’idea di giustizia, poiché non tutti si arricchivano allo stesso modo e il benessere non era diviso equamente. Il tutto portò allo sviluppo del Socialismo di Proudhon e Marx: quest’ultimo sosteneva che il libero mercato non fosse il modo migliore per utilizzare le risorse scarse al fine di rendere massima la soddisfazione delle persone; al contrario, lo stato doveva intervenire e pianificare la produzione, affinché vi fosse anche il rispetto della giustizia (= ognuno potesse avere la possibilità di godere del benessere derivante dall’uso efficiente delle risorse scarse). A questo proposito si parla di… 2) Economia pianificata (o dirigista): le persone vengono private della loro libertà, ma c’è giustizia. La storia ha dimostrato che questo modello non conduce a un utilizzo efficiente delle risorse scarse, a causa delle sue contraddizioni intrinseche: l’URSS è implosa per carestia e povertà. Tra l’altro l’economia pianificata è degenerata nella dittatura, nel culto della personalità e nelle dinastie. Dopo il fallimento dell’economia pianificata, si è comunque cercato di risolvere il problema della giustizia, cercando di rendere fasce più ampie della popolazione compartecipi del maggiore benessere. Si tratta di un problema di economia distributiva. Senz’altro la Rivoluzione industriale e la proletarizzazione portarono a un notevole miglioramento della vita media: nell’Ottocento gli operai vivevano in condizioni terribili, ma pur sempre migliori rispetto a quando erano contadini; inoltre, vi fu un aumento della durata della vita media. Marx però aveva individuato, a ragione, un difetto nel sistema del capitalismo, ovvero la tesaurizzazione: i ricchi accumulavano sempre più denaro, che però non veniva speso o reinvestito per favorire la crescita, rimanendo così improduttivo. Per risolvere il problema, i tedeschi nell’Ottocento avviarono un processo per favorire il passaggio di risorse dai più ricchi ai meno abbienti, affinché questi ultimi potessero acquistare beni e servizi che altrimenti non potevano permettersi. Trattasi del cosiddetto welfare state, promosso da Bismarck: lo stato attinge risorse da chi ha redditi e patrimoni elevati per realizzare servizi di carattere medico o assistenziale a favore dei meno abbienti. Ciò soddisfa l’esigenza di ripristinare la giustizia sociale, poiché attenua le differenze e 1 fornisce maggiori opportunità di consumo, soprattutto nell’ambito della salute e dell’assistenza. MICROECONOMIA L’economia, e nello specifico i microeconomisti*, si occupano di come funzionano i mercati, intesi come luogo di scambio di beni o servizi in libertà. *Parola che deriva dal nome inglese microeconomics: è una dottrina che si è sviluppata in Gran Bretagna a partire dal pensiero di Ricardo, che teorizzò l’idea di rendita e profitto, e di Marshall. I microeconomisti inglesi scoprirono che, a seconda del numero di persone che comprano e vendono beni e servizi, e a seconda del tipo di informazioni disponibili, si possono formare determinati livelli di prezzo per determinate quantità di merce. Quindi lo scopo dei microeconomisti è quello di trovare un giusto equilibrio tra prezzo e quantità. D’altro canto, i manager e gli imprenditori cercano continuamente di trovare un modo per evitare di sottostare alla tirannia dell’equilibrio di mercato, basata sulla perfetta coincidenza tra la quantità di prodotti offerta dalle imprese e la quantità richiesta dai consumatori (= domanda) a un determinato prezzo. Per farlo, essi aggiungono elementi innovativi ai loro prodotti, investendo sull’intangible, ovvero sul valore dell’immagine o delle informazioni relative ai loro prodotti, in modo che i loro prezzi non debbano coincidere con quelli degli stessi prodotti offerti della concorrenza. Si tratta della differenziazione del prodotto, che è alla base del brand. CONCORRENZA PERFETTA VS MONOPOLIO I microeconomisti hanno scoperto che esistono diversi casi in cui viene garantito l’equilibrio dei prezzi di mercato; uno di essi corrisponde ai mercati di concorrenza perfetta, che sono determinati da 4 fattori: 1) Il numero di chi domanda (acquirenti) e chi offre (offerenti) è talmente elevato da essere quasi infinito. 2) I prodotti o servizi scambiati sono perfettamente uguali e comparabili. 3) Tutti devono avere accesso alle informazioni complete sul prodotto e sul prezzo (per esempio, quando compro una scatola di tonno devo sapere quanto costa, gli ingredienti, la data di scadenza…). 4) L’acquisto di un prodotto o servizio presso i vari offerenti non deve implicare costi aggiuntivi (= non devono esserci i cosiddetti shoe leather costs: un prodotto deve avere lo stesso prezzo, indipendentemente dal fornitore). Queste sono le condizioni ideali per i consumatori, ma non per le imprese, in quanto queste ultime non possono aggirare le regole alzando i prezzi. In altre parole, la concorrenza toglie i privilegi e favorisce chi ha un minore potere d’acquisto, poiché essa comporta una diminuzione dei prezzi e ostacola il processo di accumulazione di ricchezza dei più abbienti (non può esserci un sovraprofitto). In aggiunta, l’aumento della concorrenza crea occupazione: se i prodotti vengono venduti a prezzi più accessibili, aumentano i consumi (perché anche i meno ricchi possono permettersi di acquistare determinati prodotti) e, pertanto, aumenta la produzione. D’altro canto, le aziende che 2 distruggono la ricchezza invece di crearla, contrastando così con il principio di utilizzo ottimale delle risorse scarse, finiscono inevitabilmente con il fallire. Il caso opposto della concorrenza perfetta è il monopolio, ovvero il caso in cui vi è un solo offerente a fronte di innumerevoli acquirenti; spesso il proprietario dell’impresa monopolista è lo stato (come nel caso del settore dei trasporti). È evidente che in una situazione di monopolio chi vende può fare quello che vuole: non essendoci il rischio che gli acquirenti si rivolgano a un altro offerente, il monopolista può non fornire loro tutte le informazioni relative ai suoi prodotti, oppure può fissare il prezzo massimo tollerabile dai suoi clienti, affinché essi acquistino una determinata quantità di merce in virtù della quale egli veda il suo profitto massimizzato. La differenza tra il prezzo imposto dal monopolista e il prezzo che sarebbe costretto a fare in condizioni di concorrenza perfetta è la rendita di posizione del monopolista. Sin dalla fine dell’Ottocento gli stati hanno emanato norme che garantissero la concorrenza nei mercati. La prima di queste fu il Sherman Antitrust Act, emanato dagli USA nel 1890, che divideva in tante società indipendenti la Standard Oil Company di Rockefeller, che aveva acquisito il monopolio nella produzione e nella vendita di petrolio. Tuttavia, nei settori caratterizzati da elevate economie di scala la dimensione della produzione è talmente importante da non consentire un numero infinito di produttori; pertanto, nei settori in cui i costi di produzione e di ricerca e sviluppo sono elevati (es. automobili o industria farmaceutica), per essere in grado di produrre un bene a costi contenuti è necessario produrlo in grandi quantità, a patto però che ci siano pochi offerenti. In questo modo cade uno dei pilastri della concorrenza perfetta, ossia quello dell’offerta illimitata: si viene a creare infatti una condizione di oligopolio tra le imprese. In questi casi gli stati consentono la concorrenza imperfetta, in quanto il risparmio di costi che essi conseguono in queste condizioni è maggiore e più conveniente rispetto al profitto derivante da un mercato di concorrenza perfetta: è vero che il consumatore paga di più, ma il costo di produzione per le aziende (e per gli stati) diventa così basso da compensare l’aumento del prezzo per gli acquirenti. LA MACROECONOMIA Oltre alla microeconomics, a partire dagli anni ’10 del Novecento l’economia politica ha sviluppato una serie di studi sul funzionamento non di singoli mercati, ma degli aggregati della società nel suo complesso: per esempio, mettendo insieme tutti i mercati troviamo il mercato dei consumi di un certo paese; se prendiamo in considerazione tutti i dipendenti all’interno di uno stato (e non limitatamente al settore delle auto o alimentare), troviamo il livello di occupazione, e così via. Questa branca dell’economia politica è chiamata macroeconomia, e analizza i consumi, l’occupazione, gli investimenti, il risparmio, i tassi di interesse, l’offerta di moneta della Banca centrale, la ricchezza di un paese (PIL), il livello delle tasse e della spesa pubblica, la presenza di un surplus o di un deficit del bilancio, il saldo degli scambi con l’estero e il tasso di cambio. LA BUSINESS ADMINISTRATION Un altro ramo dell’economia è la business administration, detta anche management o economia aziendale, che si occupa di: 3 Gestione e bilancio Marketing e sales management (come vendere meglio) HR (i.e. human resources), anche chiamata “organizzazione aziendale” Production: come ottimizzare il processo produttivo (va di pari passo con acquisti e logistica) Finanza dell’impresa (è diversa dal bilancio: riguarda banche e azionisti) Governance (o governo) dell’impresa: è l’insieme di regole che mettono in relazione coloro che investono nella società (gli azionisti) e coloro che gestiscono la società (i managers). DEFINIZIONI Istituto/Organizzazione: qualsiasi insieme di persone o cose che si uniscono per perseguire un determinato scopo. Un esempio di istituto sono le università, che possono essere viste come un insieme di persone e di attrezzature atte a progredire nella ricerca o nell’insegnamento. Impresa: è una parte dell’universo degli istituti. Le imprese sono tutti quegli istituti che hanno una finalità esclusivamente economica, ovvero produrre beni o servizi per lo scambio. Questo scopo viene perseguito secondo due modalità: per guadagnare, nel caso delle imprese for profit, oppure per scambiare risorse economiche, nel caso delle imprese non profit*. *Un esempio di imprese non profit sono le mutue cooperative, che hanno per obiettivo quello di consentire ai loro associati di poter accedere a servizi e beni a prezzi più bassi. Questo però non significa che le imprese non profit siano automaticamente for loss (cioè orientate a fare delle perdite): ogni impresa è un’entità durevole, poiché persegue l’obiettivo di mantenere un equilibrio economico il più a lungo possibile, perciò anche le imprese non profit devono cercare di sopravvivere (pur senza guadagnare) evitando le perdite. Azienda: non è né un istituto né un’impresa; è l’ordinamento economico* di un istituto. L’azienda è indispensabile in tutti gli istituti, affinché questi possano sopravvivere. Nelle imprese, in particolare in quelle for profit, l’azienda tende a coincidere con l’idea stessa di impresa (perché esse sono istituti con finalità esclusivamente economiche). *Ordinamento economico: è un insieme di persone e cose che fanno parte di un istituto e hanno il compito di gestire e sviluppare la parte economica delle attività dell’istituto stesso. Sempre secondo l’esempio di prima, un’università produce cultura, ma nel farlo una sua parte deve concentrare la propria attenzione sui costi e sui ricavi, in modo da poter pagare le strutture, i professori e gli addetti ai lavori. Altro esempio: la Fondazione Veronesi, un’impresa non profit, ha una sua azienda che ne gestisce le risorse economiche in modo da far sì che essa possa adempiere alla sua funzione primaria di ricerca e di divulgazione scientifica per la prevenzione dei tumori. Società: è l’impresa considerata a livello giuridico secondo una serie di contratti e di rapporti (può essere società di capitali o persone). 4 Bisogno: è la causa primaria della produzione e dei consumi. I bisogni sono superiori alle risorse che abbiamo a disposizione per poterli soddisfare. Una delle più grandi ambiguità della nostra epoca è che, malgrado gli enormi progressi tecnologici e organizzativi abbiano permesso di soddisfare bisogni materiali sempre più variegati, allo stesso tempo è venuta meno la corrispondenza tra maggiore produzione e maggiore soddisfacimento del bisogno, nel senso che ora una maggiore produzione può portare a una situazione di sovrapproduzione o produzione in eccesso. Un altro problema è causato dalla presenza di alcuni bisogni che l’economia non riesce a soddisfare direttamente; è il caso dell’inquinamento: nessuno può comprare aria pulita oppure una soluzione al cambiamento climatico. Secondo la teoria economica classica, quando il bisogno viene soddisfatto si genera un miglioramento del proprio benessere* (questo era vero agli albori della teoria economica, nel Settecento, ma non oggi). L’economia punta idealmente alla massimizzazione del benessere collettivo, non individuale; il problema è che quasi tutte le decisioni economiche comportano inevitabilmente il miglioramento delle condizioni di alcuni a fronte del peggioramento delle condizioni di altri. In aggiunta, l’economia non riesce a tenere conto della felicità e della qualità di vita individuale. *Qui il concetto di benessere non fa riferimento solo al benessere materiale (= possedere tanti soldi), ma include anche il miglioramento della propria qualità di vita. Il motivo per cui esistono le imprese è la parcellizzazione del lavoro, che fu introdotta a partire dalla Rivoluzione industriale e si basa sul fatto che ogni individuo svolge un solo ruolo nel processo di produzione di un bene (processo che prima veniva compiuto interamente da un solo individuo). Le imprese sono i luoghi in cui avviene la parcellizzazione e l’organizzazione del lavoro accanto alle macchine, affinché l’output prodotto sia più elevato, a parità di risorse impiegate: questo significa che la produttività è maggiore a livello di impresa rispetto che a livello individuale e artigianale. La rivoluzione industriale ha quindi comportato una riorganizzazione dell’attività umana intorno alle nuove invenzioni e un conseguente aumento della produzione. NB: l’attività principale di un manager è quella di organizzare al meglio l’attività della propria impresa, poiché è l’organizzazione che fa la differenza e permette di massimizzare l’output e il valore. LA PIRAMIDE DEI BISOGNI 5 Ogni tipologia di soggetto ha l’esigenza di soddisfare un insieme di bisogni e agisce nel sistema economico per massimizzare il proprio benessere. In base alla piramide dei bisogni di Maslow, esistono diversi tipi di bisogni. Maslow osservò i comportamenti della società americana dagli anni ’30 agli anni ’60, e notò che con l’aumento del benessere l’uomo tendeva a soddisfare bisogni via via più elevati. Normalmente guadagnano di più le imprese che soddisfano i bisogni situati in cima alla piramide. Bisogni primari: sono i bisogni prioritari da soddisfare, ovvero quelli di sopravvivenza biologica (mangiare, bere, coprirsi dalle intemperie). Bisogno di sicurezza: avere una casa, vivere in condizioni di stabilità, protezione e tranquillità, convivere con gli altri in modo civile. Bisogno di appartenenza: è l’aspirazione ad avere amici, ad avere una vita affettiva e relazionale soddisfacenti e a sentirsi integrati in un gruppo (es. social network, club di tennis). Bisogno di stima e di status: essere percepiti dalla comunità sociale come persone valide e affidabili; in alcuni casi corrisponde anche al desiderio di distinguersi dalla massa, per esempio indossando vestiti particolari o costosi, oppure adottando un determinato stile di vita particolare. Bisogno di autorealizzazione: è il bisogno più raffinato e coincide con l’esigenza di sentirsi realizzati, cioè di essere persone serene e felici; significa diventare ciò che si vuole diventare. Le attività volte all’aumento della cultura personale, come il teatro o il cinema sono strettamente connesse a questo bisogno, nel senso che un individuo può permettersi di leggere i classici latini oppure di vedere un film solo nel momento in cui gli altri bisogni sono stati soddisfatti, e queste attività spesso contribuiscono a renderlo felice. IL MARKETING Il marketing è l’attività del management che ha l’obiettivo di studiare i bisogni dei consumatori, stabilendo quali sono i prodotti o servizi necessari per soddisfarli e definendo il profilo di prezzo a cui tali prodotti possono essere comprati, nonché il modo in cui essi possono essere resi disponibili alle persone (il cosiddetto “canale di distribuzione”). Si tratta delle quattro P del marketing: 6 1) 2) 3) 4) Product Price Promotion (= comunicare le caratteristiche del prodotto) Placement (= come viene reso disponibile un prodotto) L’impresa ha un rapporto di osmosi con l’ambiente esterno, nel senso che essa riesce a sopravvivere consegnando all’ambiente più valore rispetto a quello che consuma: per produrre un prodotto vengono consumate materie prime, energia e tempo delle persone; un’impresa ha senso di esistere e di privare l’ambiente di queste risorse solo se la somma dei costi di ciò che consuma (= il prodotto) è inferiore al prezzo che un individuo è volontariamente disposto a pagare per soddisfare un determinato bisogno. In altre parole, le imprese sopravvivono solo se producono valore, il che significa che i materiali assorbiti dall’impresa devono avere un costo inferiore rispetto ai prodotti risultanti*. Il tutto è riassunto nel Teorema della mano invisibile di Adam Smith, descritto ne La ricchezza delle nazioni (1776): in un libero mercato le imprese, nel tentativo di soddisfare soprattutto i loro interessi, consentono implicitamente un miglioramento del benessere collettivo, perché sono responsabili di un’allocazione più efficiente delle risorse scarse. Chiaramente non tutti vengono soddisfatti, ma vengono soddisfatti nel massimo e miglior modo possibile. La competizione tra imprese è fondamentale per il teorema della mano invisibile, perché garantisce la sopravvivenza delle migliori, ovvero di quelle che sfruttano nel miglior modo possibile le risorse scarse. *Se compro un paio di occhiali a 100 euro, significa che per me il grado di benessere personale garantito da questi occhiali è superiore a quello derivante da un uso alternativo di quei 100 euro; in aggiunta, il mio dispiacere per aver perso quei 100 euro è inferiore rispetto al piacere che provo per aver soddisfatto il bisogno di vedere in modo adeguato. Al tempo stesso, l’impresa, che ovviamente avrà consumato meno di 100, preferisce rinunciare al paio di occhiali per avere i soldi che ho pagato (soldi che utilizzerà in parte per pagare i materiali e le persone che hanno contribuito al processo di produzione). Questo è il motivo per cui l’impresa contribuisce alla creazione del benessere collettivo della società. L’IMPRESA COME SISTEMA L’impresa è talmente complessa che non può essere gestita in maniera automatica e rigorosa da una serie di algoritmi; sono indispensabili anche le capacità di intuizione e di immaginazione dell’uomo. Negli anni ‘60 e ’70, il biologo Stuart Kauffman ha dimostrato che l’evoluzione delle specie non si basa solo sulle regole dimostrate da Darwin, in base a cui sopravvivono i più adatti all’ambiente, ma dipende anche da un processo di autoapprendimento degli organismi. Si tratta del principio di autopoiesi, termine che indica la capacità degli organismi viventi di mantenere la propria organizzazione e di imparare da soli. Questo ha spinto gli studiosi a considerare l’impresa come un organismo vivente, paragonando i suoi membri alle cellule di un corpo che acquisisce una sua identità definita. L’economia si è dunque ispirata alle discipline biologiche per formulare le teorie riguardanti l’organizzazione delle risorse e i meccanismi di funzionamento; del resto, il valore di ciò che consegna l’impresa dipende non tanto dalle risorse umane e materiali che la 7 compongono, quanto dal modo in cui queste si combinano tra di loro (in altre parole, il successo di un’impresa dipende dalla sua capacità organizzativa). Per questo motivo si tende a rappresentare l’impresa come un sistema: questa teoria ha avuto grande successo nell’Ottocento, in contrasto con l’idea positivista in base a cui la realtà era caratterizzata da rapporti deterministici di causa-effetto. Dire che le imprese sono dei sistemi equivale ad affermare che le relazioni che si creano al loro interno (i fatti aziendali) non sono basate solo su un rigido meccanismo di causa-effetto, ma che, al contrario, un determinato comportamento o una determinata azione retroagiscono, condizionando l’organizzazione delle imprese stesse (esiste quindi un rapporto di influenza reciproca). Detto altrimenti, ogni operazione compiuta in un sistema condiziona tutte le altre (presenti e future), ed è a sua volta condizionata dalle operazioni che sono state compiute in passato e che saranno compiute in futuro. Le imprese consumano energia, materie prime e risorse umane, scambiando continuamente e reciprocamente componenti con l’ambiente esterno; la loro attività deve rispettare due principi: efficienza ed efficacia. L’efficienza è la capacità di un’impresa di produrre i propri beni e servizi utilizzando la minore quantità possibile di risorse; in termini tecnici, un’impresa è efficiente se è in grado, in condizioni di libero mercato, di ottimizzare il rapporto tra input (= ciò che viene preso dall’ambiente e viene consumato) e output (= ciò che viene prodotto): il valore di tale rapporto deve essere il più basso possibile. L’efficacia, invece, è la capacità dei beni e dei servizi prodotti dall’impresa di soddisfare a un livello elevato i bisogni dei clienti che li acquistano. Chiaramente le imprese devono adempiere contemporaneamente a questi due principi (ad esempio, un’impresa non può produrre automobili di scarsa qualità pur rispettando il principio dell’efficienza). Gli scambi tra l’impresa e il sistema (fornitori e acquirenti) indicano il grado di competitività dell’impresa: un’impresa è competitiva e prevale sulle altre imprese solo se riesce a consegnare il massimo beneficio possibile con il minimo livello di consumi possibile; in questo modo, viene accettata dal sistema economico e sociale circostante. Lo scopo del management è proprio quello di migliorare l’organizzazione (e quindi la competitività) dell’impresa nel rispetto dei principi di effettività ed efficacia, ma anche quello di trovare i fornitori migliori, oppure quello di interpretare i bisogni inconsci di un cliente. In tutto ciò le imprese agiscono come dei sistemi: un sistema è definito dalle parti che lo compongono, ovvero dalla sua struttura. Queste parti devono imparare a comunicare tra di loro, ovvero devono dotarsi di uno schema organizzativo (o pattern). Quando ciò avviene, si dice che dalla struttura emerge il sistema: i manager fanno emergere l’impresa competitiva da un insieme di elementi separati (materie prime, risorse umane…). I VARI TIPI DI IMPRESE In base all’oggetto della loro attività, le imprese possono essere suddivise in: Imprese di erogazione: hanno l’obiettivo non di produrre, bensì di erogare (= distribuire) o consumare beni e servizi; esempi: pubblica amministrazione, famiglia, associazioni private. 8 Imprese di produzione: sono imprese che acquistano e producono beni e servizi per lo scambio. Imprese composte pubbliche: sono imprese che producono servizi pubblici; esempi: università, stato, regione, comune. Imprese non profit: hanno lo scopo di produrre o erogare beni e servizi non per guadagnare, bensì per soddisfare le categorie più svantaggiate o per finalità di pubblico interesse. Nel farlo, accettano di avere un profitto più basso (low profit). Imprese pubbliche: sono volte al soddisfacimento dei bisogni della collettività. Imprese mutualistiche: hanno l’obiettivo di fornire beni o servizi ai propri soci a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che troverebbero nel mercato. Le imprese di produzione (o semplicemente “imprese”) sono enti in grado di creare valore sociale per la società capitalistica liberale. Con l’espressione “creare valore sociale” si intende in primo luogo il fatto che il valore dell’output dell’impresa è superiore al valore dei consumi iniziali (input), il che genera un certo margine di guadagno per coloro che hanno organizzato l’attività dell’impresa e per gli stakeholders (= portatori di interessi). In tal senso, le imprese di produzione hanno finalità di lucro. Questo valore aggiuntivo, che è una conseguenza della mano invisibile, è dovuto al fatto che l’utilità del bene prodotto è superiore rispetto all’utilità degli elementi di input considerati separatamente (materie prime e lavoro degli operai): se, per esempio, in un’impresa vengono consumati 1 kg di alluminio (10 euro), 10 Joule di energia (3 euro) e 1 stipendio di un lavoratore (20 euro; totale 33 euro) per produrre un componente di un’automobile, e tale componente viene venduto a 40 euro, significa che l’impresa è riuscita ad aggiungere un valore (7 euro in più) ai materiali di input iniziali. In aggiunta, nel fare tutto ciò le imprese danno anche la possibilità a chi lavora di avere un reddito per comprare i beni. Dunque, il valore sociale delle imprese si traduce nel fatto che esse aggiungono utilità alle risorse scarse e forniscono la possibilità alle persone di comprare i beni prodotti. Gli stati devono però fare in modo che le imprese non depauperino altri attori della società: se i 7 euro aggiuntivi di prima derivano da una scelta arbitraria di un’impresa di aumentare smisuratamente i prezzi in condizioni di monopolio – e non corrispondono al valore effettivamente creato – allora devono intervenire gli stati, fissando una serie di normative che anche le imprese monopolistiche saranno tenute a rispettare. Certamente lo stato che fissa e fa rispettare le regole, e addirittura diventa un produttore di beni o servizi (attraverso le imprese statali), distorce la realtà per due motivi: 1) Si viene a creare un conflitto di interessi, in quanto lo stato dovrebbe assicurare che anche le sue imprese rispettino le regole di mercato da esso stabilite; 2) La gestione statale delle imprese porta a due svantaggi: in ambito pubblico vanno seguite le norme rigide e certamente più intricate del diritto amministrativo (al fine di evitare l’intervento della Corte dei Conti europea); inoltre, la corruzione è più probabile nel settore pubblico rispetto che nel settore privato, poiché un dipendente pubblico difficilmente ha le stesse motivazioni di interesse che ha un dipendente privato nei confronti del datore di lavoro e dell’impresa. Se l’impresa consuma più valore di quello che produce, essa distrugge il benessere collettivo ed è giusto che fallisca. 9 SOGGETTO ECONOMICO E GIURIDICO Sono due diverse configurazioni della proprietà di un’impresa. Il soggetto economico è quell’insieme di persone che, spinte da una visione condivisa, hanno contribuito alla nascita dell’impresa (quindi è il proprietario iniziale della medesima). Il soggetto economico possiede il potere decisionale, perciò assume le decisioni strategiche dell’impresa (creazione, definizione e protezione dell’interesse generale, estinzione…), influenzandone direttamente il destino. Il soggetto giuridico, che spesso si sovrappone a quello economico, è l’insieme di persone a cui fanno capo diritti e doveri dell’impresa, ma che non possono condizionarne direttamente le decisioni. I soggetti giuridici possono nominare i manager, che decidono in loro vece. La separazione tra queste due categorie avviene quando, con il passare del tempo, il soggetto economico assegna il diritto di decisione sulla gestione dell’impresa (e quindi sulla gestione del proprio capitale) anche a nuovi soggetti; è il caso, per esempio, delle società quotate in Borsa. Esempio: in una public company (dove il management è distinto dalla proprietà), tutti gli azionisti sono soggetti giuridici, ma non hanno il potere per influenzarne la gestione, non c’è un vero e proprio soggetto economico (lo è l’impresa in sé), e il management funge da agent. Se in una società il soggetto giuridico è frammentato – e quindi è venuto meno il pilastro dei titolari dei diritti giuridici sull’impresa – il management (= i dirigenti) prende il potere. Esistono a questo proposito diversi casi di “beneficio privato del controllo”: gli azionisti esterni che detengono il numero più elevato di azioni riescono a influenzare indirettamente il comportamento del management (che, come già detto, non viene più mitigato dalla volontà del soggetto giuridico), e si attivano meccanismi di scambio di favori tra i primi (che ottengono un beneficio privato) e l’impresa. Questo perché l’obiettivo del management non è più quello di rendere l’impresa competitiva, rispettando i principi di efficienza ed efficacia, bensì quello di mantenere relazioni con gli azionisti più forti; a rimetterci sono ovviamente gli altri azionisti, sia a causa dei minori benefici che derivano dalla cattiva gestione dell’impresa, sia perché la concessione di questi favori da parte del management comporta una serie di costi aggiuntivi per l’impresa (che di fatto viene asservita agli azionisti esterni). È la classica situazione di conflitto di interesse nelle decisioni dell’impresa. LA CONCEZIONE DELL’IMPRESA Tradizionalmente l’impresa è stata vista in modo negativo dalla società occidentale, in quanto, secondo la visione comunista, essa era considerata il luogo in cui viene prodotta la ricchezza tramite lo sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo (perché ai lavoratori non veniva dato il giusto margine di profitto che spettava loro). Paradossalmente, i sistemi comunisti oggi in vigore (Cina, Vietnam) sono caratterizzati da un sistema economico di stampo capitalista (con la libertà d’impresa) e da regimi dittatoriali che privano i lavoratori dei loro diritti. In Occidente, però, si è anche affermata l’idea che essere capaci di fare impresa è un valore che consente anche agli ultimi di emanciparsi. In aggiunta, si è passati da un’impresa unicamente orientata a creare profitto per i propri azionisti (shareholders10 oriented) a un’impresa che crea valore anche per tutti coloro che hanno un qualche tipo di interesse nei suoi confronti (stakeholders-oriented: gli stakeholders includono anche gli shareholders); ciò ha permesso di rendere l’impresa più forte e redditizia. L’impresa deve svolgere la sua attività nel rispetto delle regole (legalità) e deve contribuire al miglioramento, sul piano umanistico e sociale, dei soggetti che interagiscono con essa (gli stakeholders). In altre parole, essa deve garantire non solo lo sviluppo (concetto che rientra nell’ambito economico e materiale), ma anche il progresso (concetto che include anche la dimensione culturale, sociale e antropologica, con un’enfasi sull’identità e la dignità delle persone). Del resto, un’impresa che pensa solo allo sviluppo e al capitale viene vista negativamente, mentre un’impresa che si preoccupa anche dell’ambiente e della collettività circostanti* è certamente più apprezzata e ha più probabilità di attirare maggiori risorse (anche umane) e di mantenere i propri dipendenti. *Si parla di corporate social responsibility: se un’impresa garantisce, attraverso un sistema di welfare, un’ampia gamma di diritti e servizi ai dipendenti, è difficile che questi decidano di andarsene solo perché la concorrenza offre loro uno stipendio maggiore. Questo però è pur sempre un obiettivo secondario rispetto a quello di fare profitto rispettando le regole del mercato. Le imprese devono anche adottare determinate procedure che impediscano che vengano commessi reati al loro interno. In caso di reato, infatti, devono rispondere le imprese, non solo il singolo responsabile. Questo perché nel 2002 è entrata in vigore una legge statunitense, nota come Sarbanes-Oxley Act (SOX in breve) e introdotta in Italia con la legge 231, che ha indicato una serie di reati per i quali spetta anche all’impresa rispondere. La legge SOX prevede di fatto che le imprese adottino un “codice etico” in cui vengano specificati i valori e i comportamenti da rispettare al loro interno; stabilisce inoltre che le imprese devono dotarsi di un Organismo di vigilanza (ODV), che ha il compito di verificare che vengano attuati i protocolli e le norme previsti dal codice etico, e che le imprese abbiano adottato i protocolli adeguati per mitigare o prevenire il rischio che vengano commessi dei reati (es. corruzione). In caso contrario, una società può anche essere multata o commissariata (= il Consiglio d’Amministrazione, ovvero il management, viene esautorato e il Tribunale nomina un Commissario esterno per garantire la regolarità dei comportamenti). L’IMPRENDITORE Secondo la Costituzione italiana, l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, attività che comunemente chiamiamo impresa. Il codice civile opera una distinzione tra le varie tipologie di imprese/imprenditori basata su tre criteri: 1) L’oggetto dell’impresa, che determina la differenza tra imprenditore agricolo e commerciale. Tutto ciò che non è agricolo è commerciale, quindi il settore dei servizi rientra nell’impresa commerciale. 2) La dimensione dell’impresa: piccole imprese/imprenditori e imprese/imprenditori medio-grandi. 11 3) La natura del soggetto che esercita l’impresa: impresa/imprenditore individuale o societario. Nel primo caso, l’imprenditore richiede tutte le autorizzazioni necessarie e apre la partita IVA (un numero con cui la sua attività viene registrata come impresa presso l’anagrafe tributario). Se invece si mettono insieme più imprenditori nasce una società. L’imprenditore può essere una persona fisica o una società (= un’impresa costituita da più persone) che investe e organizza capitali, mezzi e forza lavoro (propri o altrui) per produrre dei beni o servizi da vendere sul mercato. Quello che ne ricava deve essere sufficiente a coprire tutti i costi iniziali e deve garantire un margine di profitto, detto utile (in pratica: utile/profitto = ricavo totale – costi legati alla produzione). L’imprenditore è continuamente esposto al rischio di impresa, ovvero il rischio che le spese iniziali non vengano rimborsate dai relativi ricavi, a causa della mancanza di domanda o di un mercato instabile. Un’impresa che non produce utili può diventare insolvente e, infine, fallire. L’impresa è un’attività, ossia una serie coordinata di atti unificati dal medesimo scopo (produzione e scambio di beni/servizi) e da specifiche modalità di svolgimento: sono essenziali, infatti, l’organizzazione, l’efficienza, l’effettività e la professionalità, intesa come esercizio abituale e costante (= non occasionale) dell’attività produttiva. Ovviamente i pilastri su cui si deve reggere l’impresa sono il capitale e il lavoro. LE CARATTERISTICHE DI UNA SOCIETÀ Secondo l’articolo 2247 del codice civile, la società è un accordo tra due o più soggetti che mettono in comune il proprio lavoro e/o le proprie risorse (anche monetarie) al fine di svolgere un’attività economica e di ricavarne e dividerne gli utili (scopo di lucro). NB: tutte le società sono lucrative, salvo quelle mutualistiche, che servono a far sì che i soci conseguano gli stessi beni, servizi o condizioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che troverebbero individualmente sul mercato. Nel caso delle associazioni di beneficenza, l’utile viene devoluto a determinate fasce della popolazione. NB: tutte quelle imprese collettive che esercitano un’attività economica per perseguire scopi dichiaratamente ideali, culturali, assistenziali o religiosi non sono società. IL CONTRATTO DI SOCIETÀ È caratterizzato da tre elementi essenziali: I conferimenti (= l’apporto che ciascun socio mette in comune con gli altri per iniziare l’attività): denaro, beni o servizi (es. lavoro). L’esercizio in comune dell’attività economica (detta “oggetto sociale”) per raggiungere congiuntamente lo scopo prefissato. La divisione dell’utile o delle perdite. Essere soci implica prendersi una fetta di utili o di perdite (la ripartizione non è necessariamente proporzionata al proprio apporto alla società); non si può escludere un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite. NB: ogni anno i soci decidono se mettere da parte l’utile (per acquisti futuri) oppure se distribuirlo tra loro. In genere gli utili vengono distribuiti in proporzione alla quota/azione (= al capitale sottoscritto), ma esistono anche eccezioni: in una s.n.c. a gestione familiare 12 può infatti succedere che il capostipite (il padre o la madre), in procinto di andare in pensione e non fidandosi completamente degli eredi, continui a percepire l’80% degli utili, ridistribuendoli in seguito a proprio piacimento tra i figli (indipendentemente dalla loro quota) e tenendo per sé solo il 10% degli utili. È però vietato il cosiddetto “patto leonino”: il capostipite non può mantenere la propria quota senza percepire alcun utile, in quanto è proibito, in una società di persone, escludere da utili o perdite uno o più soci. TIPI DI SOCIETÀ Le società che perseguono scopo di lucro si dividono in due gruppi: società di persone e società di capitali. Il primo gruppo include: Società semplice: è poco diffusa perché è l’unica che non esercita un’attività economica, bensì agricola. Società in nome collettivo (s.n.c.) Società in accomandita semplice (s.a.s.) Le società di capitali invece sono divise in: Società per azioni (s.p.a.) Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) Società a responsabilità limitata (s.r.l.): è il tipo più diffuso in Italia Come si diceva, tra le società di capitali rientrano anche due categorie che sono a scopo mutualistico, non lucrativo: o Società cooperativa o Società di mutua assicurazione Per attuare una “trasformazione” di una società (= la società continua la propria attività, ma in veste diversa, es. da s.n.c. diventa s.p.a.) serve un documento di “modifica dei patti sociali” firmato da un notaio. LE SOCIETÀ DI PERSONE Il nome utilizzato in diritto per identificarle è detto “Ragione sociale”, e deve comprendere almeno il nome e cognome di uno dei soci, accompagnato dall’acronimo “s.n.c.” o “s.a.s.”, dalla sede, dall’oggetto e dall’eventuale durata della società (se non specificata, significa che è a durata illimitata). Nelle società di persone è fondamentale la persona del socio: due o più persone si mettono insieme perché si conoscono e sono legate da un rapporto di fiducia reciproca relativamente alle loro qualità e capacità individuali. Se cambia la figura del socio (perché magari un socio cede la sua quota a un amico), cambiano anche le prospettive di guadagno e l’organizzazione interna, quindi bisogna modificare il contratto. I soci sono amministratori di diritto, poiché devono rispondere personalmente dei debiti contratti dalla società, anche attingendo dal loro patrimonio personale: in caso di fallimento della società, perciò, sono soprattutto loro (che mettono i soldi) a rimetterci. Alla luce di questa responsabilità, spetta ai soci decidere le strategie della società (chi sono i clienti, dove aprire un conto corrente…). A questo proposito, bisogna distinguere tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione: i primi includono tutte quelle decisioni che non 13 intaccano il patrimonio della società, per le quali è sufficiente la firma disgiunta di un amministratore (= gli affari correnti; es. se vado dal parrucchiere, uno qualsiasi dei soci incassa il prezzo della prestazione). Gli atti di amministrazione straordinaria, invece, intaccano il patrimonio della società, dunque richiedono la firma congiunta di tutti gli amministratori (es. se si decide di aprire un mutuo in banca per affittare un negozio oppure per comprare tutta l’attrezzatura necessaria). Si dice che le società di persone hanno un’autonomia patrimoniale imperfetta, in quanto se fallisce la società fallisce anche il socio; inoltre, la quota di un socio non può essere aggredita dai creditori del medesimo, che possono solo chiederne la liquidazione. Riassumendo, le società di persone sono caratterizzate da: Responsabilità illimitata dei soci, che devono rispondere dei debiti della società con i loro beni presenti e futuri -> autonomia patrimoniale imperfetta. Responsabilità solidale dei soci: un creditore può esigere da uno qualsiasi dei soci il pagamento dell’intero debito della società. Il fatto che ciascun socio, in quanto tale, è amministratore della società (salvo accordo contrario). L’intrasferibilità della qualità di socio (e delle relative quote di partecipazione) senza il consenso unanime degli altri, a causa della fiducia reciproca tra i soci. Questo vale anche in caso di decesso: i soci superstiti possono liquidare la quota agli eredi del socio defunto e continuare per conto loro, oppure possono far subentrare qualche erede capace di ricoprire lo stesso ruolo. Se invece l’apporto di quel socio particolare era indispensabile, possono addirittura sciogliere la società. LE SOCIETÀ DI CAPITALI Il nome utilizzato in diritto per identificarle è detto “Denominazione sociale”; non è necessario mettere il nome e cognome di un socio (si può anche inventare un nome), però bisogna indicare la forma (“s.p.a.” o “s.r.l.”). In seguito all’iscrizione nel registro delle imprese (tenuto dalla Camera di Commercio), la società di capitali costituisce una persona giuridica dotata di un proprio patrimonio e di propri diritti e obbligazioni, che si appoggia ai suoi organi per svolgere le azioni che normalmente compiono le persone comuni (es. acquistare un locale); al suo interno, il patrimonio dei singoli soci è distinto dal patrimonio della società. Di conseguenza, si parla di autonomia patrimoniale perfetta, il che significa che spetta alla società rispondere dei debiti, attingendo direttamente dal suo patrimonio (e non da quello dei singoli soci: anche in caso di fallimento, il loro patrimonio non viene intaccato)*. *Nelle società in accomandita per azioni, in caso di fallimento, vanno distinti i soci accomandatari (paragonabili ai soci delle società di persone: se fallisce la società falliscono anche loro) dai soci accomandanti, che perdono al massimo quello che hanno investito nella società. Questo vale anche per le società di persone in accomandita semplice (s.a.s.), che comprendono il socio accomandatario, che amministra e gestisce l’impresa (e deve pagare di tasca sua eventuali debiti), e il socio accomandante, che apporta denaro solo occasionalmente e approva il bilancio una volta all’anno (quindi non rischia di fallire, a patto che non abbia preso decisioni di carattere amministrativo). 14 Va aggiunto che nelle società di capitali la “partecipazione sociale” (= il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti la vita della società) rappresenta un bene dotato di un valore economico autonomo, distinto da quello della società*. Ne deriva che, mentre nelle società di persone la modifica di un socio implica una modifica del contratto istitutivo, nelle società di capitali tale evento incide solo sul patrimonio del socio uscente e di quello subentrante, ma non interessa la società nel complesso. *NB: nelle società per azioni (s.p.a.) la partecipazione sociale è detta quota, mentre in quelle a responsabilità limitata (s.r.l.) è detta azione. In sintesi, le società di capitali sono caratterizzate da: Responsabilità limitata dei soci: essi rischiano solo il denaro che hanno investito nella società. Il fatto che essere soci non comporta necessariamente la possibilità di prendere decisioni relative all’amministrazione della società: nelle grandi società vengono spesso eletti degli amministratori esterni (amministratori delegati o manager), dunque non sempre il socio è anche amministratore, tranne nelle piccole società. Il fatto che la qualità di socio è liberamente trasferibile (sia per cessione volontaria sia per decesso): non è richiesta nessuna modifica del contratto di società e dipende esclusivamente dalla volontà del socio in uscita. Questi tre punti si spiegano tenendo in considerazione che la persona del socio ha un’importanza secondaria nelle società di capitali: chi vi partecipa, infatti, lo fa solo in quanto detentore di ricchezza, non grazie alle sue qualità o capacità personali. Tuttavia, per motivi di fiducia, nelle società di capitali viene spesso aggiunta una clausola di gradimento in caso di recesso di un socio: se un socio A vuole cedere la propria quota al socio B, è necessario che il socio A informi l’Assemblea dei soci (l’organo amministrativo, vedi di seguito) e che quest’ultima approvi l’entrata del socio B. Esiste anche il diritto di prelazione (= il diritto di essere preferito): se il socio A intende cedere la sua quota al socio B, lo comunica a C e D. Se il socio B non interessa a C e D, questi possono chiedere di comprare la quota di A. Infine, in caso di morte del socio A, può capitare che gli imprenditori, non fidandosi degli eredi, si riuniscano in assemblea per decidere se liquidarli tutti o farne entrare uno nella società. Da queste tre eccezioni, si deduce che si tende a conferire una certa prevalenza al diritto dell’impresa rispetto che al diritto degli eredi (nel senso che, per esempio, i superstiti possono liquidare gli eredi senza che questi possano entrare di diritto nell’impresa). LE SOCIETÀ PER AZIONI La s.p.a. è idonea per le imprese che richiedono un ingente apporto di capitali e che comportano l’assunzione di notevoli rischi. Come già accennato nel paragrafo sulle società di capitali, la s.p.a. nasce in seguito alla redazione di un atto notarile pubblico e alla stipulazione del contratto sociale (detto atto costitutivo) e delle norme che la regolano (statuto). Una volta confermata la legalità del tutto, la s.p.a. viene iscritta nel registro delle imprese e acquisisce una personalità giuridica; la sua gestione è affidata unicamente agli amministratori, non ai soci. Il minimo di capitale stabilito dalla legge per l’istituzione di 15 una s.p.a. è di 50.000 euro, somma che viene poi suddivisa in varie porzioni, dette azioni e rappresentate da titoli, che sono una misura della partecipazione di ciascun socio alla società. I soci godono di diritti amministrativi e patrimoniali; i primi includono: Il diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee (che si devono riunire almeno una volta all’anno per approvare il bilancio) Il diritto di impugnare (= contestare) le delibere assembleari non conformi alla legge o allo statuto Il diritto di denunciare i “fatti censurabili” al Collegio sindacale I diritti patrimoniali, invece, comprendono: Il diritto alla ripartizione degli utili, dei debiti e, in caso di fallimento, del residuo attivo (= quello che rimane una volta estinti i debiti) Il diritto all’assegnazione di azioni GLI ORGANI DELLA SPA Al pari di tutte le persone giuridiche, la s.p.a. è tradizionalmente dotata di vari organi incaricati di adempiere allo scopo per cui è stata istituita: L’assemblea dei soci: è l’organo sovrano della società, in quanto ha il potere di nominare gli amministratori e i membri dell’organo di controllo, nonché di deliberare su determinati argomenti, come l’approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili. Va sottolineato che le decisioni dell’assemblea devono essere comunicate a tutti i soci, anche a quelli che hanno la percentuale minore di quote (diritto all’informativa). Ci sono due tipi di assemblea: o Assemblea ordinaria: svolge le funzioni riportate sopra, determinando anche il compenso e l’eventuale revoca degli amministratori. È previsto un quorum più basso per prendere le decisioni. o Assemblea straordinaria: può stabilire un aumento di capitale o una modifica dello statuto o dell’atto costitutivo. L’organo amministrativo, che ha il compito di gestire il funzionamento, le strategie e l’operato della società, come anche di convocare l’assemblea. Può essere composto da un solo amministratore o più amministratori che, in tal caso, costituiscono il Consiglio di amministrazione (CdA), eleggendo un presidente o un eventuale amministratore delegato che rappresenti la volontà della società all’esterno e in giudizio (ruolo che viene svolto dal singolo amministratore, nel primo caso). Il CdA può anche delegare alcuni poteri agli amministratori delegati, organi individuali che servono a compiere determinate azioni senza dover convocare tutto il Consiglio (a cui però devono sempre rendere conto); inoltre, al suo interno possono anche formarsi dei gruppi più ristretti di amministratori, detti comitati esecutivi. NB: non tutti i poteri possono essere delegati: è il caso della redazione del bilancio o dell’aumento del capitale sociale. Gli amministratori devono rispondere del loro operato verso la società, i singoli soci, i creditori sociali, ed eventualmente verso soggetti terzi. 16 Un organo di controllo e di revisione, che può essere chiamato collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato di controllo, e verifica che gli amministratori abbiano osservato la legge e lo statuto. I membri del collegio sindacale hanno un mandato della durata di tre anni e devono possedere competenze tecnico/professionali (devono essere commercialisti iscritti in appositi albi). NB: il suo è un controllo di legalità, non di merito, nel senso che non può stabilire a priori che una decisione amministrativa non è adeguata per il successo dell’impresa. GLI ORGANI DI CONTROLO ESTERNI Il revisore legale dei conti: può essere una società o una persona fisica; deve controllare che il bilancio sia stato formulato in maniera corretta (controllo contabile). La CONSOB: è un organo pubblico che serve a tutelare e a garantire una maggiore trasparenza per gli investitori. L’autorità giudiziaria (Tribunale): i soci vi ricorrono quando sospettano che vi siano state gravi irregolarità nella gestione della società (art. 2409). LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (S.R.L.) Si costituisce sempre previa formulazione di un atto pubblico notarile, ma il capitale minimo è di 10.000 euro e non può essere rappresentato da azioni: i soci ne acquisiscono una frazione chiamata “quota”, che può essere ulteriormente suddivisa (a differenza delle azioni). Un’altra differenza rispetto alle s.p.a. è che nelle s.r.l. gli amministratori possono ricoprire l’incarico a tempo indeterminato; inoltre, non è necessario l’organo di controllo (nel caso, deve essere composto da un solo sindaco), in quanto il controllo viene effettuato direttamente dai soci, che possono chiamare un commercialista. Oggi i soci possono decidere se costituire una s.r.l. la cui disciplina si avvicini a quella della s.p.a. (nei limiti di quanto detto poc’anzi per le s.r.l.) oppure a quella delle società di persone, in modo da assegnare più rilevanza alla figura del socio (es. tutti i soci sono amministratori), pur conservando il beneficio della responsabilità limitata. Va anche segnalato che, se per esempio una s.r.l. di Milano decidesse di trasferire la propria sede all’estero, prevarrebbe il voto dei soci con la percentuale di quote maggiore (= se un socio ha il 70% del capitale, il suo parere prevale su quello dell’altro socio con il restante 30%; quest’ultimo può adeguarsi alla situazione oppure recedere dalla società, chiedendo che gli venga data la quota che gli spetta). In caso di scioglimento o di fallimento, la s.r.l. non cessa immediatamente di esistere: vengono nominati uno o più liquidatori, e la società può solo portare a termine i contratti in corso, senza però stipularne di nuovi. Spetta ai liquidatori estinguerne i debiti, distribuendo quanto rimane successivamente tra i soci. Dal 2012, il legislatore italiano ha previsto la possibilità (inizialmente solo per i minori di 35 anni) di costituire delle s.r.l. con un capitale minimo di 1 euro e inferiore a 10.000 euro (società a responsabilità limitata semplificata): il notaio redige l’atto notarile gratuitamente, ma l’atto costitutivo viene stabilito dalla legge e non può essere modificato. In realtà, però, a causa del loro basso capitale iniziale, le s.r.l.s. non sono prese seriamente in considerazione all’estero. NB: nelle s.r.l. l’apporto può essere formato da 17 danaro o da beni*, e bisogna versarne solo il 25% alla banca; nelle s.r.l.s. l’apporto deve essere conferito solo in danaro e per intero, e i soci devono essere persone fisiche. *Quando il patrimonio viene conferito in natura (= sotto forma di beni, es. un immobile), occorre che il valore del bene venga valutato attraverso una perizia, in quanto esso costituisce una garanzia per i creditori. La perizia viene normalmente realizzata da commercialisti esterni, che vengono eletti dal tribunale (nelle s.p.a.) o dai soci (nelle s.r.l.) e devono giurarla, assumendosi le loro responsabilità legali. Affinché una perizia sia valida, non devono trascorrere più di 60 giorni dal suo giuramento. È un modo per impedire che i soci “barino” sopravvalutando i loro beni e prendendosi una fetta di utili maggiore del dovuto. Riassumendo somiglianze e differenze tra s.r.l. e s.p.a.: S.p.a. Azioni liberamente trasferibili, senza modifica di contratto Responsabilità limitata Conferimenti in danaro o beni/servizi Almeno 50.000 euro per costituirle Capitale diviso in azioni Incarico a tempo determinato (3 anni) per gli amministratori Organo di controllo obbligatorio S.r.l. Quote liberamente trasferibili, senza modifica di contratto Responsabilità limitata Conferimenti in danaro o beni/servizi Almeno 10.000 euro per costituirle Capitale diviso in quote Incarico a tempo indeterminato per gli amministratori Organo di controllo facoltativo (massimo 1 membro) GESTIONE, STRATEGIA, TATTICA Come si è visto, l’impresa in quanto tale è definita in primis dalla capacità di organizzare le proprie risorse umane, finanziarie e materiali, assicurandosi che tutte le proprie componenti si muovano secondo una visione unitaria. Lo scopo primario dell’impresa (che la rende etica) è quello di creare valore, il che significa che, in condizioni di libero mercato, i prezzi pagati dai clienti sono superiori a quelli pagati dall’impresa per acquistare le risorse e le materie prime. Quindi, attraverso il processo di produzione che si svolge all’interno delle imprese, è possibile aggiungere un valore alle materie assorbite dal sistema economico; tale processo può essere suddiviso in: acquisto, trasformazione/produzione, vendita. Il valore di un prodotto finale, però, deriva anche da come viene svolto il processo di vendita, specialmente nel caso del settore dei servizi: quando il supermercato compra i barattoli di Nutella dalla Ferrero, esso non li trasforma ulteriormente, ma si limita a renderli disponibili alla gente ordinaria. In questi casi, quello che conta è il modo in cui la produzione viene resa disponibile al mercato: non è dunque vero che il settore dei servizi non aggiunge valore ai prodotti; al contrario, in questo campo entra in gioco la componente “soft” dell’economia, che include marketing, design, comunicazione, logistica, ricerca e sviluppo, e così via (= tutto ciò che contribuisce al cosiddetto “storytelling”). Ciò rende il settore dei servizi la vera forza del sistema economico, essendo una delle sfere che genera maggiore occupazione. 18 L’organizzazione può essere vista sotto due aspetti. Il primo aspetto è incentrato sui tempi e i metodi di trasformazione: coordinando persone, risorse materiali e rispettive mansioni attraverso le varie fasi del ciclo di produzione, deve essere garantita la massima efficienza; il secondo aspetto, invece, si basa sull’elemento del capitale umano, ossia nel senso di appartenenza al team e nella condivisione dei valori dell’impresa: un buon manager deve anche saper creare un forte clima organizzativo tra le persone (deve essere una sorta di psicologo). Pertanto, un’organizzazione adeguata non deve essere incentrata solo sulle componenti meccaniche dell’impresa, ma deve tener conto anche della partecipazione dei dipendenti ai valori della medesima. Il tipico esempio di organizzazione esclusivamente “meccanica” è quello dell’organizzazione statale-burocratica (pubblica), che ha portato l’URSS al tracollo. I MODELLI ORGANIZZATIVI L’azienda è fondata essenzialmente su tre elementi: il sistema delle risorse umane, il sistema dei beni (risorse materiali) e il sistema delle operazioni (organizzazione). Di estrema importanza è la fase di attribuzione dei compiti e delle mansioni ai vari dipendenti, secondo le combinazioni più opportune per raggiungere gli obiettivi aziendali. Per farlo, si applicano i cosiddetti “modelli organizzativi”, che rendono ciascuna azienda un unicum rispetto a tutte le altre. Si tratta di 3 diversi insiemi di principi che determinano le decisioni del management di un’impresa e che, quindi, sono alla base della sua struttura e dei suoi meccanismi organizzativi* (in pratica, il modello definisce la struttura e i comportamenti dell’impresa, mentre la struttura è solo una parte del modello). L’adozione di uno dei 3 modelli dipende dalla complessità di ogni organizzazione, dalle risorse disponibili, dalle strategie decise dai propri soggetti economici, dalla tipologia di prodotto/servizio offerto e dall’ambiente generale e specifico. L’ambiente generale include svariati fattori esterni all’impresa di carattere tecnologico, politico, legale e, soprattutto, culturale (ideali, norme sociali), demografico e sociologico. L’ambiente specifico, invece, comprende tutti quei soggetti fisici o giuridici che interagiscono con l’impresa. Può capitare che, nel corso della sua vita, un’impresa adotti diversi modelli organizzativi a seconda della sua evoluzione. *I meccanismi organizzativi sono le modalità, all’interno di una struttura, con cui interagiscono tra di loro le componenti di un’impresa. Ci sono tre tipi di meccanismi organizzativi: formale-rigido (basato sulle regole amministrative, che non lasciano alcun grado di libertà ai dipendenti; è tipico della burocrazia, del diritto amministrativo e delle imprese pubblico-statali), formale-aperto (basato su una serie di procedure gestionali, che lasciano un più ampio margine di libertà), e informale (basato sulla consuetudine, non su direttive scritte). Tutte le imprese cercano di adottare meccanismi formali-aperti, perché sono quelli che favoriscono maggiormente la produzione. In generale, ogni impresa deve adottare un sistema di organizzazione e di controllo in grado di individuare le aree di rischio, garantire che le risorse a disposizione siano impiegate in maniera adeguata e prevedere sanzioni in caso di comportamenti interni illeciti. IL PRIMO MODELLO: LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA ELEMENTARE 19 È tipico delle imprese con pochi dipendenti, che non devono gestire particolari complessità. Tale modello spesso viene applicato all’inizio della vita di un’impresa, ed è caratterizzato dal ruolo preponderante dell’imprenditore, ovvero il proprietario, nelle cui mani è concentrato il potere di direzione, coordinamento e controllo. È evidente che tale struttura è gerarchica, essendo finalizzata a rispondere alle domande e ai desideri dell’imprenditore (si parla di imprese “one man one business”). Presenta il vantaggio della chiara identità del pensiero, della comunicazione immediata e dell’agilità operativa, con costi di organizzazione e comunicazione ridotti. Allo stesso tempo, però, è gravata dal limite della mancanza di una visione plurale e di un sistema di checks and balances (freni e contrappesi). Un esempio di struttura organizzativa elementare è l’impresa artigianale o l’impresa a conduzione familiare o imprenditoriale (nella conduzione imprenditoriale è assente la dialettica tra componenti della famiglia, che permette di ridurre il rischio di decisioni monopolistiche). Il capo è sempre necessario, ma è fondamentale anche l’accountability, cioè il dover rispondere del proprio operato, con il rischio di essere rimossi o di fallire in caso di cattiva gestione. Spesso il ruolo dell’imprenditore diventa corrotto quando il meccanismo di elezione delle persone che ruotano intorno a lui si fonda su meccanismi che non tengono conto delle capacità dell’individuo: è il caso dei cosiddetti “cerchi magici”, termine che indica il gruppo di persone che si forma intorno al capo in virtù della simpatia personale o della fiducia/fedeltà (i rapporti imprenditoriali basati esclusivamente sulla fiducia sono gravemente compromessi; ci si dovrebbe basare sulla lealtà, ovvero la fedeltà alla verità). Nella struttura organizzativa elementare un ruolo importante viene svolto anche dall’addetto alla contabilità e all’amministrazione (sono competenze tecniche, che spesso l’imprenditore capo non possiede, ma che hanno una funzione puramente formale), dall’addetto alla produzione e dall’addetto alla rete di vendita. In genere, se l’imprenditore è un buon artigiano assume un addetto alle vendite, mentre se è un bravo commerciante assume un addetto alla produzione e all’amministrazione. IL SECONDO MODELLO: LA STRUTTURA FUNZIONALE 20 Il termine “funzione” indica la modalità di realizzazione di un determinato fine durante lo svolgimento generale di un’attività. Nella cornice dell’attività dell’impresa, dunque, i vari membri si specializzano nello svolgere funzioni, ossia compiti particolari e diversi gli uni dagli altri. Tali compiti dipendono dalle finalità intermedie che vengono assegnate alle diverse parti dell’impresa, eppure, nonostante la loro specificità, si integrano gli uni con gli altri, contribuendo al funzionamento generale della medesima e permettendole di adempiere al suo obiettivo ultimo, ovvero creare valore. Tra le finalità intermedie (dunque tra le funzioni) rientrano: La direzione (o funzione) acquisti: l’insieme di persone che devono comprare le risorse alle migliori condizioni possibili e con le giuste tempistiche; La direzione del marketing: coloro che cercano di capire se un prodotto avrà successo, tenendo in considerazione le 4 P; La direzione vendite: coloro che vanno a vendere il prodotto (è diversa dal marketing); La direzione dell’amministrazione e della finanza, che si occupa della contabilità interna (o “controllo di gestione”). Il suo capo è il CFO, che è l’alter ego del CEO (amministratore delegato); La direzione di produzione: coloro che dirigono l’attività di trasformazione delle risorse all’interno dell’impresa; La direzione del personale (human resources), che ha il compito di motivare i dipendenti; La direzione legal and tax: coloro che si occupano dei controlli sul piano legale e fiscale. Normalmente, nella struttura funzionale il capo (CEO) si avvale di diverse persone che gestiscono ognuna una funzione diversa e che devono riportare direttamente a lui (per questo sono dette “primi riporti”): queste hanno autonomia nella direzione della loro funzione specifica, ma devono perseguire il fine stabilito dal CEO o dal management. Dallo schema si evince che tutte le funzioni rispondono al direttore generale, eccetto la funzione 21 di auditing, che ha lo scopo di verificare che una società possieda una struttura e delle procedure adeguate per svolgere correttamente la propria attività, e che tali procedure vengano effettivamente rispettate dagli addetti ai lavori. Per esempio, le persone incaricate di effettuare un audit sulla funzione acquisti devono controllare se i suoi dipendenti lavorano in modo adeguato e se sono previste procedure che evitino il rischio di una cattiva qualità nelle consegne (NB: l’auditing non è un’attività contabile, ma è un’attività di controllo effettuata in prospettiva consultiva, e non punitiva). L’audit può anche proporre miglioramenti al gestore di una funzione e persino all’Amministratore delegato o alla Direzione generale; del resto, i membri dell’auditing non devono rispondere al Direttore generale, ma devono avere un’indipendenza tale da poter formulare analisi critiche e proposte di cambiamento adeguate. Essi fanno capo o al Presidente della società (che non svolge un ruolo operativo) oppure al cosiddetto Comitato audit, che fa parte del Consiglio d’amministrazione. Oggi il valore di un’impresa si misura non solo in termini di utili e di rendimento, ma anche in termini di performance, espressione che fa riferimento sia ai risultati evidenti per tutti (utili) sia al profilo di rischio che l’impresa deve sostenere per ottenere tali risultati (il rischio è una componente nascosta ai non addetti ai lavori). Per evitare un calo di reputazione o, addirittura, di finire in cause penali, le imprese devono ridurre al minimo possibile i rischi (a tal scopo interviene anche l’audit, segnalando le aree critiche): ciò contribuisce a migliorare la loro performance. Questo perché utili elevati in presenza di rischi elevati valgono meno di utili leggermente inferiori a fronte di rischi bassi (perché i primi potrebbero anche trasformarsi in perdite impossibili da gestire per l’impresa). Il rischio della struttura funzionale è la mancanza di un coordinamento adeguato tra la base e i vertici dell’impresa; bisogna anche tenere presente che questo modello richiede l’emissione e la circolazione di molti documenti per poter funzionare in modo appropriato, il che aumenta i costi interni di produzione (che sono costi non direttamente produttivi). I VANTAGGI DELLA STRUTTURA FUNZIONALE La struttura funzionale presenta 4 diversi vantaggi che la rendono attrattiva, contribuendo all’efficienza e all’efficacia. Il primo è la capacità di rendere minimi i costi fissi per unità di prodotto dell’impresa. A differenza dei costi variabili, il cui ammontare dipende dalla quantità di merce prodotta e dal processo produttivo, i costi fissi, pur non essendo rigidamente invariabili, non sono meccanicamente collegati all’output dell’impresa. Per esempio, in una centrale elettrica la quantità di metano e di carbone che viene consumata dipende dalla quantità di kW che deve essere prodotta (costo variabile), ma lo stesso non si può dire per lo stipendio del direttore (costo fisso). In base a questo esempio, sembra che per migliorare il profilo dei costi fissi di un’impresa basti aumentarne la produzione (in modo da ottenere maggiori ricavi). In realtà, però, esiste una soglia di produzione oltre la quale il costo fisso si collega all’output: se si decidesse di raddoppiare il numero di turbine per incrementare i kW prodotti, quel singolo direttore da solo non sarebbe più in grado di controllare tutta la produzione (e quindi andrebbe assunto un altro direttore, raddoppiando i costi fissi). In conclusione, è vero che per ottimizzare i costi fissi bisogna aumentare la produzione, tuttavia va anche tenuto in 22 considerazione il concetto complementare di “capacità produttiva” garantita da una certa struttura (= la massima quantità di output che un’impresa può realizzare con quella struttura). Più ci si avvicina al limite della capacità produttiva, più aumentano i rischi, tra cui quello che i clienti parlino male dell’impresa perché non soddisfatti del suo prodotto. Suddividere un’attività in varie funzioni consente a tutta l’impresa di beneficiare del lavoro di ogni singola funzione, ottimizzando i costi fissi: per esempio, se alla IULM la funzione marketing organizzasse l’open day, sicuramente l’università pagherebbe un costo fisso per retribuire gli addetti ai lavori, però beneficerebbero di tale spesa tutte le facoltà allo stesso tempo (interpretariato, arte e turismo, comunicazione…); la IULM eviterebbe così duplicazioni dei costi fissi per l’open day. Il secondo vantaggio della struttura funzionale è che consente di sfruttare le economie di scala, che non sono direttamente collegate all’aumento della quantità prodotta. Il termine “scala” deriva dall’inglese scale (rapporto) e fa riferimento a quelle economie che permettono alle imprese di ridurre al minimo i costi medi di produzione a fronte di un ingrandimento degli impianti, grazie allo sfruttamento di un rapporto proporzionale tra i diversi fattori produttivi. Tre fattori determinano le economie di scala: 1) L’interazione delle linee produttive. Esempio, in una società che produce bevande, il processo produttivo è suddiviso in 4 fasi: creare la bottiglia, mettere l’etichetta, versarci il liquido e avvitare il tappo. Per ragioni meccaniche, non è detto che lo svolgimento di ogni fase in un’unità di tempo avvenga con la stessa velocità delle altre: poniamo il caso che la macchina impiegata nelle prime due fasi crea 3 bottiglie ogni 2 secondi (1,5 bottiglie al secondo), mentre la macchina che si occupa di immettere il liquido riesce a riempire solo una bottiglia al secondo. È evidente che la prima macchina deve lavorare a 3/4 della propria capacità produttiva per rispettare il ritmo della seconda. All’imprenditore astuto conviene dunque applicare la legge del minimo comune multiplo (m.c.m. tra 1,5 e 1 = 3) e dotarsi di 2 macchine che creano le bottiglie (2mac x 1,5bot x 1s= 3bot/s) e 3 macchine che le riempiono (3mac x 1bot x 1s= 3bot/s), in modo che vengano completate 3 bottiglie ogni secondo. Ecco perché nell’economia di scala non conta tanto la quantità prodotta, quanto piuttosto che le diverse fasi siano combinate in modo proporzionale nel tempo. 2) La funzione di riserva, di capacità e di servizio. In ogni attività produttiva è essenziale tenere anche in considerazione il costo dei mezzi di riserva: se l’ATM prevede che ogni 10 tram 1 tram si fermi, deve avere pronto un tram di riserva che subentri quando uno degli altri entra in pausa. In base a questo rapporto, l’azienda dovrebbe prevedere 2 tram di riserva qualora circolassero da 10 a 20 tram; chiaramente, per ottimizzare il margine di riserva, all’ATM converrebbe far circolare 20 tram invece che 12 o 13, in modo da “spalmare” su più mezzi possibili il costo del tram di riserva aggiuntivo. In conclusione, la quantità di macchinari da tenere come riserva per evitare la rottura del ciclo produttivo costituisce un’economia di scala. 3) La legge del cubo quadrato. Mentre i costi si sviluppano secondo una legge di metri quadrati, i ricavi si sviluppano secondo una legge di metri cubi. Prendiamo in 23 considerazione gli oleodotti: il costo per realizzarne uno dipende dalla quantità di superficie che occupa (quindi dalla lunghezza); il ricavo è determinato dalla quantità di liquido che passa dentro il tubo, che dipende dal diametro della sezione del tubo e dalla velocità di trasporto del fluido. Ne deriva che costruire oleodotti comporta costi che crescono al quadrato (in base all’area ricoperta -> m2) e ricavi potenziali che crescono al cubo (in base al volume dell’interno del tubo -> m3). NB: un aumento eccessivo delle dimensioni di un’impresa può portare al gigantismo, ovvero a una situazione in cui, nonostante la società sfrutti i vantaggi delle economie di scala, i costi di coordinamento e controllo della struttura aumentano eccessivamente e non si è più efficienti. In questo caso si parla di diseconomie di scala. Il terzo vantaggio della struttura funzionale è costituito dalle economie di scopo, cioè dal fatto che lo svolgimento di una certa attività consente di conseguire ulteriori obiettivi o benefici, senza creare costi aggiuntivi. Esempio: il fine delle grandi compagnie aeree internazionali che effettuano voli oltreoceano è quello di avere l’aeroporto più importante di tutti (detto hub). Mettiamo che Air France voglia organizzare un volo da Milano a New York: per riempire l’aereo che effettua il volo transoceanico, essa garantisce ai clienti un primo volo gratuito che fa scalo al Charles de Gaulle (hub) di Parigi. In questo modo, più clienti vengono “invogliati” ad acquistare il biglietto Milano-New York (perché include solo il costo del volo Parigi-New York) e Air France non ci perde, perché il costo che ha pagato per il volo Milano-Parigi (che avrebbe dovuto effettuare in ogni caso) verrà rimborsato dalla maggiore affluenza di clienti che pagano il volo intercontinentale. Una delle applicazioni dell’economia di scopo è l’economia circolare, in cui i prodotti scartati vengono riutilizzati. Per esempio, una società che produce succhi spreme le arance ma poi usa la buccia per creare delle essenze, ottenendo quindi due prodotti (succo ed essenza) e più valore, a fronte di un costo e di un processo produttivo unico (si parla anche di stretching of the value chain). La quarta fonte di risparmio garantita dalla struttura funzionale è costituita dalle economie di esperienza: inizialmente si sbaglia, però si apprende attraverso vari tentativi come svolgere in modo più efficiente una certa attività, risparmiando il più possibile sui costi. Per esempio, i primi televisori realizzati da un’impresa molto probabilmente avranno dei difetti (minore know-how = peggiore qualità), poi alla luce dei feedback dei clienti essa sarà in grado di apportare una serie di modifiche utili ai propri prodotti. NB: i costi fissi e le prime due economie si basano sulle quantità prodotte nell’unità di tempo. Al contrario, le economie di esperienza prendono in considerazione il numero complessivo di tentativi effettuati nel tempo per compiere una determinata azione. Di conseguenza, mentre nei primi tre livelli bisogna organizzare la produzione tenendo conto dell’unità di tempo, nelle economie di esperienza è necessario produrre in grandi quantità, perché il successo dipende appunto dalla sommatoria dei beni prodotti. Esempio: inizialmente una società può vendere a 95 euro i televisori che ha fabbricato pagando 100 euro: in questo modo tiene testa alla concorrenza e, allo stesso tempo, ha la possibilità di “sperimentare”, producendo e vendendo in grandi quantità e aumentando così lo storico della sua produzione (= la somma dei televisori che ha prodotto). Poiché nelle economie di 24 esperienza il costo unitario* diminuisce a fronte di un aumento dello storico della produzione, l’impresa riuscirà nel lungo periodo a compensare la perdita iniziale di 5 euro, in quanto le spese di produzione scenderanno al di sotto dei 95 euro: questo perché tale società, grazie ai vari tentativi effettuati per produrre televisori, avrà acquisito sempre più efficienza (= avrà imparato a fabbricarli meglio spendendo meno). *Il costo unitario è il costo medio di ogni singola unità, e corrisponde al rapporto tra il costo totale affrontato per produrre un bene e la quantità di beni prodotti (Cunit = Ctot/Q). Se il costo totale diminuisce, anche il costo unitario diminuisce. LA STRUTTURA DIVISIONALE Il termine “divisione” indica ognuna delle diverse partizioni, o unità operative, che avvengono all’interno della struttura delle imprese (es. la Balilla ha la divisione pasta, la divisione sughi… sono prodotti diversi e complementari, non concorrenti. La divisione è quindi una sorta di impresa nell’impresa). Ogni divisione ha le proprie risorse e le proprie funzioni, e si dedica a un business specifico; un “business” è una combinazione tra la definizione di un certo prodotto, l’esistenza di un certo mercato disposto a comprarlo, e il modo in cui si produce (in sintesi, prodotto + mercato + tecnologia, fattori che differiscono da un business all’altro). Non esiste una chiara posizione della dottrina aziendale che stabilisca se convenga o meno dotarsi di più divisioni, anche se fino agli anni ‘60 si prediligevano le imprese multi-business, o corporation, in quanto esse presentavano rischi ridotti: se un settore (e una divisione) va male, viene bilanciato dal successo di un altro settore. Tale meccanismo di controbilanciamento è detto “effetto di portafoglio” o “effetto derivante dalla diversificazione del rischio”. In realtà, però, si è scoperto che crea più valore un’impresa che è focalizzata su un singolo business rispetto a un’impresa diversificata, dato che spesso il consumatore preferisce decidere in prima persona la propria diversificazione (nel senso che magari può scegliere di comprare solo la pasta della Balilla, ma non il sugo). Tra l’altro, in una multi-business vi è il rischio di cadere nelle diseconomie di scala o nella duplicazione di alcune funzioni, e i costi di gestione e di coordinamento sono assai elevati. Un ulteriore svantaggio è che le multi-business tendono a investire le risorse dei business che hanno successo nei business che invece riscontrano varie difficoltà, invece di chiuderli; in questo caso, il management mostra un atteggiamento conservativo, poiché attua un sovrainvestimento di risorse a vantaggio di una divisione che dovrebbe fallire. Infine, bisogna tenere in conto che l’immagine negativa di una certa divisione potrebbe influire negativamente sulla reputazione delle altre. 25 Come si nota dallo schema, il modello divisionale prevede una prima ripartizione in varie divisioni (pasta, succhi, biscotti) e una seconda ripartizione, all’interno di ciascuna divisione, in una serie di funzioni (ricerca e sviluppo, acquisti e produzione, marketing e vendite). Nell’impresa multi-business è necessario che ci sia un organo di staff (vedi prossimo schema) che garantisca il coordinamento tra le attività delle varie divisioni in una prospettiva corporate (= di capogruppo): per esempio, nella Balilla le funzioni marketing e vendite della divisione pasta, della divisione biscotti e della divisione succhi avranno ciascuna il proprio direttore marketing, ma sarà necessario anche un direttore marketing “corporate” che abbia una visione d’insieme dell’attività svolta da tutti i direttori marketing e che li coordini. Questo direttore corporate, come si diceva, costituisce un organo di staff con lo scopo di supportare il Direttore Generale, il quale ha l’unica responsabilità di stabilire gli obiettivi del gruppo e di controllare che ogni divisione stia operando in modo efficiente ed efficace. LA STRUTTURA A MATRICE 26 Il modello a matrice è una variante della struttura divisionale e racchiude strutture funzionali collegate in modo verticale tra loro (es. la funzione “risorse acquisti” o “risorse HR” delle linee pasta, biscotti e succhi), a cui si aggiungono elementi di coordinamento orizzontali tra le divisioni. Nello schema, gli organi di staff menzionati prima corrispondono alla “Direzione Acquisti”, la “Direzione Produzione”, la “Direzione Marketing e Vendite”, la “Direzione HR” e la “Direzione Amministrazione, contabilità e controllo”. In pratica, i responsabili delle funzioni “Risorse acquisti”, “Risorse produzione”, “Risorse Marketing e Vendite”… devono rispondere sia al Direttore della Divisione (Linea) di riferimento, sia alla “Direzione Acquisti”, alla “Direzione Produzione” ecc, a seconda della Funzione di cui fanno parte (con la possibilità che insorgano conflitti tra le direttive delle due Direzioni). A loro volta, le Direzioni di funzione e di divisione dipendono dalla Direzione Generale (o Amministratore delegato), che ne esercita il controllo e il coordinamento, definendo strategie e obiettivi. NB: le Direzioni di ogni divisione dipendono strategicamente dalla Direzione generale, ma non hanno rapporti tra sé stesse. In presenza di una struttura organizzativa così articolata, è ovvio che è necessario garantire un buon coordinamento tra le parti. Questo non significa produrre il numero più elevato possibile di informazioni, altrimenti si vengono a creare dei costi fissi troppo elevati (sunk costs); serve un adeguato sistema di produzione di informazioni che partano da ciascuna divisione/funzione e vadano al direttore generale o al management, un sistema organizzato che eviti la diffusione di informazioni ridondanti. Questa comunicazione di ciò che avviene all’interno di ogni divisione è detta sistema di reporting, termine che indica l’insieme di informazioni gestionali, economiche e finanziarie (= di contabilità industriale*, o controllo di gestione), che devono essere chiare, organizzate, tempestive (per applicare con anticipo dei correttivi in caso di criticità) e trasmesse con una frequenza prestabilita. 27 *La parola “contabilità” non fa riferimento solo al bilancio di esercizio, che è utile solo per gli esterni che hanno interessi nei confronti dell’impresa, bensì a un complesso di dati numerici (il budget) che servono al management per capire come sta procedendo la gestione di una divisione o di una funzione e per risolvere eventuali criticità che possono rendere inattuabili i programmi prefissati; il bilancio d’esercizio avviene dopo che è stato redatto il budget. I GRUPPI DI IMPRESE NB: non vanno confusi con le imprese multi-business, dove ogni divisione è priva di un’autonomia societaria o giuridica. Un gruppo di imprese è governato da un’impresa cosiddetta “holding”, che detiene una serie di partecipazioni in altre società; tale forma di controllo si verifica nonostante l’autonomia giuridica e societaria di ogni impresa, ma l’attività di coordinamento è più tenue rispetto a quella della struttura divisionale (perché ogni impresa mantiene un grado di autonomia più elevato rispetto alle divisioni all’interno di una singola società). Per esempio, Marchionne ha diviso la FIAT originaria in 3 società autonome (che prima erano divisioni della FIAT) – Ferrari, Fiat Chrysler Automobiles, e Fiat Case New Holland – di cui la società Exor, controllata dalla famiglia Agnelli, è azionista di maggioranza (Exor è quindi la società di holding del gruppo). Esistono tre diversi tipi di rapporti tra la holding e le partecipate: 1) Rapporto di controllo: si verifica quando la holding detiene la maggioranza dei voti nell’assemblea della sua partecipata (in pratica, il suo voto controlla automaticamente il voto dell’assemblea). Il rapporto di controllo non implica necessariamente che la holding abbia il 50% + 1 dei voti; basta che essa eserciti un’influenza dominante nell’assemblea: l’UniCredit, ad esempio, controlla Fineco pur detenendo una partecipazione pari al 35%, in quanto il 65% restante non riesce a coordinarsi e a creare una maggioranza di blocco; ci sono anche alcune norme che stabiliscono che determinati azionisti possono godere del diritto di voto plurimo, a prescindere dalla quantità di azioni possedute. In Francia, per esempio, se un azionista detiene una partecipazione da più di un anno, il peso del suo voto raddoppia (quindi l’investitore stabile vale di più rispetto a quello speculativo). Infine, si ha un rapporto di controllo anche quando una holding, pur non dominando l’assemblea della partecipata, è in grado di decretarne indirettamente la vita o la morte grazie a una serie di vincoli contrattuali: è il caso delle imprese subfornitrici, che vendono i loro prodotti solo a un cliente e, pertanto, dipendono implicitamente dalla volontà di quest’ultimo. 2) Rapporto di collegamento: si verifica quando una holding esercita un’influenza rilevante su un’altra società (perché ne possiede parte delle azioni). Nel caso delle società quotate, la holding deve detenere almeno il 10% della partecipata. 3) Rapporto di correlazione (o d’interessenza): avviene quando una società, attraverso il controllo, esercita un condizionamento totale sull’altra (grazie al “premio di maggioranza”). In questo caso bisogna verificare che il controllante non si approfitti della controllata e che le operazioni tra le parti correlate avvengano in 28 condizioni di libero mercato (altrimenti gli azionisti di minoranza della controllata si troverebbero danneggiati: la controllante potrebbe prendersi tutti gli utili oppure relegare loro tutti i debiti della controllata). Perciò, nelle società quotate dove c’è il rischio di rapporti tra parti correlate (ossia del già accennato “beneficio privato del controllo”), devono esserci dei consiglieri indipendenti nominati dalle minoranze che assicurino che le operazioni tra le parti correlate avvengano nel rispetto delle regole del mercato. Un altro rischio è che qualora una holding (es. Exor) vendesse le proprie azioni, il loro prezzo sarebbe di gran lunga superiore a quello delle azioni vendute da chi non è in grado di influenzare il management della società quotata; questo perché le azioni della holding includono anche il controllo delle decisioni dell’assemblea, detto “premio di maggioranza” (è un’altra declinazione del beneficio privato del controllo). Per evitare questa situazione, molti paesi hanno introdotto la regola dell’OPA (Offerta Pubblica d’Acquisto) obbligatoria: quando un controllante cede le partecipazioni di una società quotata a un determinato prezzo, esiste l’obbligo per l’acquirente di offrire a tutti gli altri soci lo stesso prezzo in cambio delle loro azioni (è un modo per mitigare il beneficio privato del controllo). La scelta di un soggetto economico di formare un gruppo risponde a diverse esigenze, per esempio consolidare la propria posizione in un certo mercato (grazie all’acquisizione di imprese operanti al suo interno), aumentare di dimensioni (con tutti i vantaggi che ne derivano, es. costi fissi, economie di scala, scopo…), internazionalizzarsi ed entrare in nuovi settori di business, oppure suddividere la propria impresa in varie società che operano ciascuna in un determinato settore, in modo da ridurre i costi di gestione (vedi esempio della FIAT fatto poc’anzi). INTEGRAZIONE VERTICALE E ORIZZONTALE Integrazione verticale: processo che comporta l’acquisizione, da parte di un’impresa, di altri soggetti economici che operano in diverse fasi dello stesso ciclo produttivo. Per esempio, un’azienda che produce mobili e che si occupa solo della fase di verniciatura dei medesimi può integrarsi verso l’alto (a monte), acquisendo un’impresa che si occupa della fase di taglio e levigatura del legno, oppure verso il basso (a valle), acquisendo un’impresa che si occupa dell’assemblaggio e della vendita del prodotto finito. L’integrazione verticale è dovuta a esigenze quali: aggirare barriere tecnologiche o commerciali riguardanti i prodotti intermedi; controllare l’acquisizione dei prodotti di input (nel caso venga acquisita un’impresa che si occupa di logistica in entrata); coordinare l’intero processo produttivo di un bene. Lo svantaggio principale è rappresentato dall’elevata complessità gestionale e burocratica tipica delle strutture di grandi dimensioni. Integrazione orizzontale: processo di acquisizione, da parte di un’impresa, di altre imprese concorrenti che operano nel medesimo settore. Per esempio, un'impresa che opera nel settore degli elettrodomestici e che produce lavatrici e lavastoviglie assorbe un'impresa che opera nello stesso settore ma che produce frigoriferi. Entrambe le imprese sono accomunate dagli stessi cicli di lavorazione, da tecnologie simili e dalle stesse politiche di distribuzione. L'integrazione orizzontale permette di ampliare la propria quota di mercato e sfruttare le sinergie tra due linee di prodotto complementari tra loro. 29 GESTIONE, TATTICA, STRATEGIA Gestione: è basata sull’organizzazione e sull’implementazione di una funzione aziendale. In generale la gestione riguarda l’insieme delle operazioni propedeutiche al processo di acquisto, produzione e vendita. In pratica, nella gestione ci si chiede quali azioni concrete bisogna attuare e come occorre organizzarsi per rendere il più efficiente possibile l’acquisto, la produzione e la vendita; non ci si sofferma a pensare quale mercato sia più adeguato per l’impresa oppure quali strategie adotterà la concorrenza. Tattica: è un livello un po’ più sofisticato rispetto alla gestione. Le attività tattiche non riguardano l’esecuzione efficiente di attività operative, bensì consentono di acquisire vantaggi su un piano più complesso. Una tattica tipica riguarda le politiche di vendita realizzate da un’impresa (es. lancio una campagna di sconti per vendere i miei prodotti); non si tratta di operazioni in serie, che eseguo costantemente, bensì di operazioni opportunistiche, che eseguo occasionalmente per catturare delle opportunità. Strategia: le decisioni strategiche sono quelle più critiche per un’impresa, in quanto assorbono una grande quantità di risorse e comportano scelte difficilmente reversibili che avranno conseguenze nel medio o nel lungo termine, a differenza di quelle di gestione, che hanno un effetto nel quotidiano (una volta che ho preso una decisione di tipo strategico, resterò immobilizzato su quel determinato percorso). Esse vengono assunte in seguito a un’analisi detta “complessa”, perché tiene conto di diverse variabili che bisogna cercare di anticipare, capendo la combinazione dell’una con l’altra. Chiaramente scegliere la strategia di un’impresa significa anche programmarne la realizzazione. A tal fine, bisogna anzitutto stabilire le finalità e gli obiettivi generali di un’impresa (oltre a quello naturale di sopravvivere), individuando ad esempio un prodotto o un mercato che le consentirà di essere più forte dei propri concorrenti. D’altronde, la strategia serve proprio a essere più competitivi e più forti della concorrenza, e per farlo l’impresa deve creare più valore per i propri clienti, scegliendo la struttura organizzativa più adeguata e manager che consegnino nel miglior modo possibile i risultati rispetto alle esigenze del mercato. Dopo aver definito le finalità generali, bisogna determinare le politiche dell’azienda (= come comportarsi) e gli obiettivi intermedi necessari per attuarle (chiaramente le politiche devono essere in linea con le finalità generali). Per esempio, nel caso della FIAT una finalità generale potrebbe essere quella di diventare il leader dei crossover negli USA e in Europa, mentre un obiettivo intermedio potrebbe essere investire nella ricerca sui SUV. Per conseguire gli obiettivi intermedi vanno realizzati dei programmi, ossia descrizioni delle attività da svolgere nel breve periodo e delle risorse materiali e umane necessarie. Sono infine fondamentali il monitoraggio e l’eventuale adeguamento dei programmi: monitorare significa controllare e assicurarsi che questi programmi possano effettivamente essere realizzati; in caso contrario bisogna applicare un processo “omeostatico a retroazione”, ovvero bisogna fare un passo indietro. In sintesi, una volta definita una strategia a livello teorico per rendere competitiva l’impresa, il passo successivo è la pianificazione strategica, cioè il processo che permette di individuare da un lato le sue finalità generali, dall’altro le procedure e gli obiettivi intermedi necessari per realizzarle. La pianificazione strategica rappresenta pertanto la modalità 30 attraverso cui si mette in pratica la strategia dell’impresa; i suoi obiettivi generali devono poter essere raggiunti gradualmente e devono essere condivisi da tutti i soggetti che fanno parte dell’azienda, soggetti a cui devono essere comunicati con chiarezza i vari tempi di realizzazione degli obiettivi intermedi. La direzione della pianificazione strategica spetta al soggetto economico, che è costituito dai vertici della società (NB: non è detto che i vertici coincidano con i proprietari di quell’impresa; spesso infatti l’Assemblea nomina i manager, e non gli azionisti, come amministratori). Il problema è che in questo modo la strategia dell’impresa viene fatta da persone (i manager) che non rischiano il proprio capitale: ciò crea un’asimmetria di rischio, perché in caso di errori il manager rischia solo il posto di lavoro, ma non i capitali investiti (manca l’accountability, ovvero la necessità di rispondere del successo o dell’insuccesso delle proprie decisioni); di conseguenza, i manager tendono a prendere decisioni rischiose, sapendo che le conseguenze di eventuali fallimenti ricadranno su qualcun’altro. Dal canto loro, se gli azionisti vedono che un’azione va male, cambiano i manager (è la “teoria dell’agenzia”: il principal, ovvero l’azionista, delega la determinazione della strategia all’agent, ovvero il manager; tuttavia, se gli interessi dei due non convergono, avviene una crisi). Per ottenere elevate performance, bisogna assicurare una relazione di sinergia tra strategia, struttura e ambiente in cui si opera. Il primo libro di strategia della storia fu scritto nel 1961 da Alfred Chandler Jr. (Strategy and structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise), che fu il primo a definire il concetto di strategia, precisando che non si può piegare la strategia alla struttura dell’impresa, ma bisogna adeguare la struttura alla strategia. A sua volta, la strategia è determinata dal mercato, che ha anche un ruolo morale: Smith intuì che nel libero mercato c’è una tendenza ai comportamenti corretti che ne fanno l’interesse (teoria dei sentimenti morali: è corretto ciò che fa l’interesse del mercato). La pianificazione strategica implica anche il saper fare pre-visioni, ossia essere in grado di vedere prima qualcosa che ci sarà, immaginando gli scenari in cui ci troveremo tra un determinato periodo di tempo alla luce della situazione attuale, in modo che l’impresa sia in grado di adeguarvisi (non previsioni nel senso astrologico o divinatorio). In altre parole, la pianificazione strategica serve a classificare gli eventi secondo la loro rispettiva probabilità di verificarsi, abbinandovi poi le azioni necessarie per assicurare la governabilità degli stessi. Una strategia deve perseguire il massimo livello di efficacia e di efficienza possibile. A tal fine, le varie economie di scala, di scopo e di apprendimento permettono di migliorare l’efficienza di un’impresa, ottimizzando il rendimento delle risorse di input in rapporto all’output e permettendo quindi di risparmiare sui costi medi unitari di un prodotto e di essere più competitivi. La pianificazione strategica può definirsi su 3 livelli: A livello corporate: è il livello a monte, e riguarda il modo in cui un’impresa mette insieme e coordina diversi business, che realizzano prodotti diversi tra loro, destinati a mercati diversi. Questo livello, in pratica, riguarda le corporation, o conglomerati.* 31 A livello di business: significa comprendere la combinazione tra prodotto, mercato (e concorrenza) e tecnologia; a volte, per esempio, capire come sfruttare al meglio una determinata tecnologia rende più competitivi. A livello funzionale: decidere quali strategie di marketing, di comunicazione, di posizionamento del prodotto o di prezzo adottare (è il livello a valle della pianificazione strategica, è di carattere esecutivo). Va ricordato che la funzione è un insieme di persone che si distingue dal resto dell’organizzazione perché si dedica a un’attività mirata e specifica all’interno dell’impresa; le funzioni non sono isolate tra loro, ma vengono coordinate dai manager. *Il concetto di corporation fu segnalato per la prima volta nel libro The Modern Corporation and Private Property (1932) da Berle e Means, che avevano notato che negli USA si era diffuso un nuovo modello di imprese, ossia le public companies (o corporation), grandi società in cui coesistono diversi business (es. la General Electric). La pianificazione a livello corporate non si occupa dei singoli business (quella è pianificazione di business), bensì del modo in cui combinare vari business diversi per generare valore aggiuntivo: se ad esempio metto insieme in un’unica corporation un business A che vale 100 e un business B che vale 50, tale corporation può valere magari 170, e quel 20 aggiuntivo deriverà esclusivamente dalla sinergia e dalla combinazione tra i due business (non fa parte del loro valore intrinseco). Se invece una corporation non dà origine a una sinergia (= componente di valore aggiuntivo che deriva dall’unione di più business) allora è meglio attuare uno split, cioè separare i business (nel caso, per esempio, in cui i costi di coordinamento e di gestione siano troppo elevati: span of control). Oggi si dice spesso che le imprese devono concentrarsi esclusivamente sul loro core business per avere successo ed essere più efficienti (perché occupandosi solo di quello si riducono i rischi di dispersione); ovviamente però ciò comporta maggiori rischi di estinzione, in quanto se il core business va male, fallisce l’impresa. IL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI E DEI BUSINESS Per capire la logica con cui le imprese ricavano valore per il semplice fatto di aver unito più business, vanno considerati due elementi che li differenziano: 32 La natura dei business (es. produzione aerei, motori, lampadine…). Il livello di anzianità o maturità dei prodotti realizzati da quel business: i prodotti, infatti, seguono un proprio ciclo di vita (nascita, sviluppo, maturità e declino), perciò in ogni linea possono esserci prodotti che presentano un diverso livello di maturità. Un’ottima strategia corporate dovrà assicurare che ogni business sia caratterizzato da prodotti distribuiti in fasi diverse del ciclo di vita: non devono esserci tutti prodotti in fase di maturità, altrimenti quel business sarebbe in fin di vita; al contrario, il business deve continuare a evolversi. Volendo fare un esempio, la FIAT produce prodotti in fase di maturità (Punto e Panda), prodotti tra la fase di sviluppo e quella di maturità (500 e Crossover) e prodotti innovativi, che devono ancora attraversare la fase di crescita (ibridi e auto elettriche). Questo ciclo di vita interessa anche i business stessi: oggi esistono business maturi in cui è impensabile rinnovare i prodotti a causa di una serie di innovazioni esterne; è il caso per esempio del settore automobilistico, di fronte alla diffusione sempre più frequente del car sharing oppure del trasporto ad alta velocità. Ne deriva che una buona strategia corporate non solo dovrà cercare di estrarre economie di scala e di scopo (= sinergie) dall’unione di vari business, ma dovrà anche tener conto del ciclo di vita dei business in quanto tali (e non dei prodotti*), in modo da evitare che core business maturi non vengano sostituiti da core business più giovani dopo la loro morte. Questo perché sono frequenti i fenomeni di value migration, vale a dire che il vantaggio competitivo tende a essere eroso. *Un’impresa può anche essere all’avanguardia nella produzione di auto con motore diesel, ma il problema è che il business del motore diesel è ormai maturo e si sta avvicinando al declino. LA MATRICE DEL BOSTON CONSULTING GROUP 33 È legata all’analisi del ciclo di vita di un prodotto e combina la quota di mercato relativa a un prodotto specifico (che ne indica la forza) con il tasso annuale di crescita del mercato di quel prodotto. I prodotti con un’alta quota di mercato e che fanno parte di un mercato con un alto tasso di crescita sono i prodotti “star”, caratterizzati da utili elevati e da un flusso di cassa equilibrato; dovrebbero essere i prodotti di punta di un’azienda. Ci sono poi i “cash cow”, ovvero prodotti maturi con un’alta quota di mercato relativa, ma che fanno parte di un mercato che non cresce quasi più; essi, pertanto, generano molta liquidità ma sono a fine corsa, non è conveniente investire in un loro ulteriore (e improbabile) sviluppo. Il nome deriva dal fatto che è meglio “mungerli” e mantenerli vivi finché è possibile trarne dei profitti. I “question mark” sono prodotti poco forti che rappresentano vere e proprie scommesse, poiché il mercato di appartenenza è in forte crescita; di conseguenza, generano pochi utili e presentano un flusso di cassa negativo, in quanto richiedono molti investimenti ma non è detto che acquisiranno valore sul mercato. In poche parole, potrebbero diventare prodotti star o “dog”, ossia prodotti con una bassa quota di mercato che non crescono più. LA MATRICE DI ANSOFF È un altro modo per ricavare il valore derivante dallo stare insieme. Non si occupa del ciclo di vita di un business, bensì prende in considerazione il fattore rischio: come già detto in precedenza, solo una valutazione che tenga conto sia del rendimento sia del rischio potrà fornire una corretta misura dei risultati (performance) dell’impresa. Ansoff si chiede se è possibile creare del valore aggiuntivo mettendo insieme business diversi, affinché dalla loro combinazione derivi almeno un minore rischio complessivo (se non un migliore 34 rendimento). In base al principio della diversificazione del rischio, formulato nel 1952 da Markowitz, la risposta è sì: infatti, la correlazione dei risultati di diversi business può influire sul rischio complessivo dell’impresa. Per esempio, se io da investitore compro azioni della FIAT e della Volkswagen, ho acquisito attività con un elevato livello di correlazione tra loro, perché rientrano nello stesso mercato (correlazione positiva). Si tratta di una decisione assai rischiosa, perché qualora il mercato delle auto fallisse, fallirei pure io: in questo caso, il rischio dell’insieme è uguale al rischio di ciascun business. Però se investo in attività decorrelate (correlazione negativa), non è detto che l’andamento negativo di un business influenzerà l’altro; anzi, i due si compenseranno, abbassando il rischio complessivo. Quindi solo unendo business diversi e negativamente correlati posso ridurre il rischio globale dell’impresa. Negli anni ’70, tuttavia, ci si è resi conto che la diversificazione viene attuata più spesso dall’investitore rispetto che dall’impresa; questo perché l’investitore tende a essere più razionale rispetto ai manager, i quali invece preferiscono, per esempio, tenersi persino un business “dog” oppure business positivamente correlati tra loro, pur di evitare perdite di potere e di cash flow. In poche parole, i manager prediligono i titoli “value”, che garantiscono una buona liquidità ma non hanno grandi prospettive di crescita (meno rischi nell’immediato), mentre gli imprenditori preferiscono i titoli “growth” (es. startup). Ansoff ha chiarito che la scelta di combinare business diversi per ridurre i rischi implica un’analisi dei mercati e dei prodotti relativi a ciascun business; in pratica, si mettono a confronto i mercati (e i prodotti) dei diversi business, per vedere se sono uguali e già esistenti, oppure diversi e innovativi. Se compro un business che produce prodotti nuovi per un mercato nuovo, si dice che ho compiuto un’operazione di “diversificazione” (vedi tabella), assumendomi ovviamente maggiori rischi. Se invece compro un business che realizza prodotti vecchi per un mercato già esistente, si tratta di un’operazione di “penetrazione” (es. Facebook quando ha comprato Instagram, oppure FIAT che compra Chrysler); il vantaggio è che conosco già quel mercato (ma mantengo gli stessi rischi). Si parla infine di differenziazione quando c’è una novità o nel prodotto o nel mercato. Gli investitori non vedono di buon’occhio la diversificazione, a causa dei rischi a lungo termine. STRATEGIA DI BUSINESS: IL MODELLO DELLE 5 FORZE COMPETITIVE DI PORTER 35 Passando dalla strategia corporate a quella di business, questo modello permette di capire la forza di un singolo business (prodotto + mercato + tecnologia), che a sua volta dipende dal livello di competitività dell’impresa. La nostra idea di concorrenza corrisponde a quella diffusa fino agli anni ’80, in base a cui sono “concorrenti” tutti quelli che svolgono la mia stessa attività. In seguito, Michael Porter ha capito che il rischio di perdere il proprio vantaggio competitivo non dipende solo dai concorrenti, ma anche da altri variabili (infatti il suo è anche detto “modello della concorrenza allargata”). La prima è il rischio che si diffondano prodotti sostitutivi in un determinato mercato: l’Alitalia si è sempre confrontata con altre compagnie aeree come la Lufthansa, ma il principale concorrente si è rivelato il treno ad alta velocità, che è diventato un prodotto sostitutivo dell’aereo. Un’altra variabile sono i concorrenti potenziali, ovvero quelli che capiscono che in un settore si guadagna tanto e perciò decidono di entrarvi e di vendere i loro prodotti a un prezzo inferiore; tale rischio è maggiore se un’impresa detiene il monopolio in un determinato settore, traendone un elevato rendimento (es. prima lo yogurt greco costava molto perché era prodotto solo da FAGE; ora lo vendono anche Carrefour ed Esselunga, a un prezzo di gran lunga inferiore). In questo caso, l’unico modo per difendersi è avere delle barriere, ad esempio i brevetti oppure la disponibilità esclusiva di un bene intermedio necessario per realizzare il prodotto. Le ultime due variabili sono i fornitori e i clienti: il livello di competitività dell’impresa è determinato anche dalla sua capacità di lavorare insieme a questi ultimi. Mentre un tempo il rapporto con il cliente e il fornitore era basato solo sul prezzo (era un gioco a somma zero: più prendo io meno prendi tu), ora si cerca di cooperare per ricavare maggiore valore dalla filiera (e far sì che entrambe le parti ne ricavino qualcosa in più). Bisogna però stare attenti a non crearsi un nuovo concorrente con questo procedimento, come nel caso di Benetton e Zara (che era un subfornitore di Benetton). 36 LE 3 MACROSTRATEGIE COMPETITIVE Le imprese competono per essere più forti dei propri concorrenti, in modo da ottenere migliori risultati economici e finanziari e ricavare così un profitto. NB: “profitto” non significa solo ottenere degli utili, ma è la capacità di ottenere degli utili aggiuntivi rispetto a quelli che si otterrebbero in condizioni di concorrenza perfetta (ovvero avere una redditività più alta rispetto alla concorrenza). Per farlo, un’impresa deve riuscire ad acquisire un vantaggio competitivo, adottando una strategia competitiva vincente. Esistono 3 macrostrategie tra cui scegliere: Leadership di costo: grazie alla propria dimensione, l’impresa è in grado di avere un livello di costi strutturalmente inferiori rispetto a quello dei propri concorrenti. Le maggiori dimensioni, infatti, portano una serie di vantaggi (costi inferiori) che prescindono dalla capacità dell’impresa di essere ben organizzata. La prima causa di risparmi di costi grazie alle dimensioni è rappresentata dallo sfruttamento dei costi fissi (a patto che si eviti di saturarli e si mantenga un margine di capacità produttiva di riserva); ci sono poi i risparmi che si possono ottenere non solo grazie alla quantità prodotta, ma anche alle relazioni che esistono tra le diverse fasi del ciclo produttivo (le economie di scala, le economie di scopo e le economie di esperienza). Le imprese che puntano alla leadership di costo devono saper catturare questi vantaggi. Differenziazione: essere migliore della concorrenza perché offro prodotti con caratteristiche diverse dagli altri (è la strategia tipica della moda, del design o dell’alimentazione: es. convinco la clientela a comprare un mobile non perché serva, ma perché è un oggetto d’arte). La differenziazione si basa sull’esperienza, la comunicazione e lo storytelling: molte imprese oggi sono competitive anche per i servizi, ossia per la componente immateriale di immagine e di esperienza che aggiungono al prodotto. Se si persegue questa strategia il vantaggio non deriva dal prezzo di produzione più basso, ma è anzi dovuto al prezzo più alto dei prodotti che vendo. Strategia di nicchia: realizzare prodotti di nicchia, cioè prodotti con caratteristiche di rarità e unicità più marcate rispetto al prodotto differenziato (i prodotti di nicchia sono spesso legati allo stile: l’AUDI è differenziata, mentre la Ferrari è prodotto di nicchia, al pari, per esempio, del tartufo o del Barolo). Come si diceva, una qualsiasi di queste 3 strategie permette all’impresa di godere di un vantaggio competitivo e di avere una redditività maggiore (profitto) rispetto ai concorrenti della concorrenza perfetta, ossia a quelle imprese che non si distinguono per nessuna di queste 3 strategie. Il vantaggio competitivo però va anche mantenuto, in quanto tende ad evolversi; pertanto, il management deve essere in grado di rigenerarlo costantemente e, per farlo, non deve ripetere in continuazione quello che si è sempre fatto, bensì deve puntare sull’innovazione di processo (= orientata a rendere più efficiente il processo produttivo) o di prodotto (= dotare i prodotti di caratteristiche più apprezzate dai consumatori). VALUE CHAIN E SWOT 37 Porter ha anche individuato i modi con cui generare il vantaggio competitivo attraverso le attività dell’impresa, a prescindere dalle varie strategie competitive. Ha creato perciò la value chain, in cui vengono distinte due tipologie di attività: Attività primarie: alimentazione del processo produttivo (“logistica in entrata”), produzione (“operations”), vendita e consegna dei prodotti (“logistica in uscita”), e servizio post-vendita (per conferire maggiore valore all’utilizzo di un bene). Sono le attività di base dell’impresa. Attività di supporto: servono ad assicurare il buon funzionamento di ogni attività primaria. Si tratta della politica di acquisti, della capacità di fare innovazione (“sviluppo tecnologico”), dell’organizzazione aziendale (“human resources management”) e delle infrastrutture fisiche dell’impresa (macchinari, uffici, stabilimenti…). Le imprese devono saper coordinare sia le attività primarie sia quelle di supporto, in modo da poter consegnare “margine”, ossia valore. La SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) è un altro modo per analizzare le capacità competitive di un’impresa, a livello di business. Essa consente di evidenziarne i punti di forza e di debolezza, come anche le opportunità e i rischi, in modo da poter poi scegliere la strategia competitiva più adatta che permetterà di costruire o rigenerare un vantaggio competitivo. L’imprenditore che compie tale analisi deve valutare ogni elemento di carattere economico, culturale, politico, finanziario e tecnologico (anche a livello internazionale) che potrebbe influenzare negativamente o positivamente il raggiungimento degli obiettivi da parte dell’impresa; deve anche prendere in considerazione la possibilità di creare alleanze con altre imprese per potenziare l’efficienza ed efficacia della sua. La SWOT, che andrebbe effettuata prima della pianificazione strategica, è uno strumento utile, in quanto può aiutare a trasformare una minaccia in un’opportunità, oppure a capire quali sono i punti di forza di un’impresa, affinché essa possa renderli immuni ai rischi e sfruttarli al meglio per essere più competitiva. IL BUDGET 38 In un’impresa non si parla solo di controllo, bensì di “sistema di pianificazione e controllo”, in quanto non avrebbe senso eseguire solo il controllo senza la pianificazione e la programmazione, e viceversa. Controllare, infatti, significa guardare l’andamento delle attività dell’impresa, ma per giudicare se stanno andando bene o male serve un termine di paragone, che è appunto rappresentato dalla pianificazione e dalla programmazione, attività che permettono di prefigurare in anticipo l’andamento dell’impresa. La pianificazione riguarda ciò che accadrà nel medio-lungo termine (nell’arco di circa 3-5 anni) e serve a individuare delle tendenze di comportamento da adottare; la programmazione, invece, serve a stabilire quello che accadrà nell’immediato (6-12 mesi), perciò consente di definire in modo più puntuale i risultati da raggiungere. Abbiamo già sottolineato che queste due attività non coincidono con il prevedere (nel senso di indovinare) il futuro: non sono attività di divinazione, bensì la conseguenza di un processo logico e razionale in cui si cerca di prefigurare cosa dovrà fare l’impresa, chi dovrà guidarla, come dovrà farlo (quali risorse umane e materiali utilizzare) e così via. Una volta realizzata la programmazione, si potranno scrivere i relativi numeri; il documento che li contiene è il budget*, che solitamente viene redatto verso fine anno per cercare di prefigurare i comportamenti dell’impresa nell’anno successivo. *In generale, quindi, il budget è un documento che contiene i numeri relativi agli obiettivi e alle strategie dell’impresa, inclusi gli elementi economici, gestionali e patrimoniali (risorse) necessari al loro raggiungimento. Esso permette di programmare le azioni e l’andamento futuri dell’impresa alla luce di tutti i possibili scenari economici, ma anche di motivare le risorse umane, migliorandone il livello di specializzazione, come vedremo tra poco. Molte volte la direzione chiede a ciascuna funzione di fare il proprio budget a partire da una serie di obiettivi di budget concordati in precedenza: in questo caso, a livello di funzione, chi fa il budget deve partire dagli obiettivi dati dalla direzione per capire di quali risorse e persone ho bisogno per raggiungerli. La costruzione del budget, pertanto, può essere bottom-up (ogni funzione comunica alla direzione quali obiettivi si è prefissata) o top-down (l’alta direzione fissa degli obiettivi e le varie funzioni devono dire di quali risorse avranno bisogno per raggiungerli). Di solito l’alta direzione non si accontenta del procedimento bottom-up, bensì cerca di fissare una serie di obiettivi impegnativi per le funzioni. Bisogna sottolineare che il budget deve essere oggetto di negoziazione, non deve essere imposto dall’alto: se la direzione stabilisce obiettivi realistici e raggiungibili su cui sono d’accordo le varie funzioni, ne beneficerà tutta l’impresa, poiché le persone che hanno negoziato il budget si sentiranno più motivate. Se invece viene imposto un budget irrealistico, le persone si sentiranno scoraggiate. Insieme al budget bisogna anche creare un sistema incentivante, ossia il sistema premio-sanzioni (anche se oggi non si parla tanto di sanzioni, quanto di “mancata premialità”: gli operai vanno integrati, non marginalizzati attraverso le sanzioni): i premi sono compensi extra dati alle persone qualora compiano o superino gli obiettivi prestabiliti, che chiaramente non devono essere automaticamente raggiungibili (altrimenti i dipendenti non sono motivati a spingersi al di là delle proprie capacità). 39 In conclusione, grazie al budget è possibile migliorare il processo di comunicazione interna tra l’alta direzione e le risorse umane, come anche l’organizzazione nel suo complesso (perché a ogni funzione aziendale vengono attribuiti determinati compiti e responsabilità). Inoltre, il budget consente un’analisi razionale della realtà aziendale e dell’ambiente in cui un’impresa opera, al fine di ottimizzare l’impiego di risorse e fronteggiare i cambiamenti che provengono dall’esterno. NB: il budget non indica solo il numero di utili finali, ma anche la struttura di costi e ricavi che porteranno a un certo risultato: in questo modo, quando si effettuerà il controllo si andranno a vedere le differenze tra quello che si è programmato e che si è fatto non solo alla fine, ma fase per fase. Quanto appena detto fa parte dell’analisi degli scostamenti, che è contenuta nel reporting e permette al management di capire dove intervenire e quali provvedimenti adottare per rimuovere le cause degli scostamenti e riallinearsi con l’andamento stimato (es. i manager dovranno decidere se intervenire sull’efficacia del processo produttivo o sulla negoziazione dei prezzi di vendita o di acquisto). Quest’analisi dovrà tener conto dell’importanza e delle cause di ogni scostamento, dell’esistenza a monte di errori di pianificazione e dell’eventuale presenza di fattori esterni che non è possibile controllare. Va ricordato che, affinché il controllo di gestione garantito dal sistema di reporting abbia effetto, la circolazione di tutte queste informazioni deve essere semplice, chiara e, soprattutto, tempestiva, affinché la direzione possa applicare in anticipo dei correttivi; in aggiunta, il budget deve essere costantemente monitorato e aggiornato, perché gli scenari interi ed esterni all’impresa possono sempre mutare, ovviamente. Riassumendo: Normalmente prima va fatto il piano strategico, poi il budget. Il piano strategico rientra nell’attività di pianificazione, ed è la programmazione degli obiettivi dell’impresa nei prossimi 3-5 anni. Esso comprende la definizione delle risorse e delle strategie da attuare per raggiungere gradualmente tali obiettivi e la valutazione delle alternative possibili e delle relative conseguenze. Non va rifatto ogni anno, in quanto esiste il rolling planning, 40 che consiste nel riscrivere, alla fine di ogni anno, il piano strategico dei 3-5 anni successivi, aggiornando i dati relativi all’anno appena trascorso in base ai risultati ottenuti e adattando eventualmente gli obiettivi prefissati alla luce del proprio vantaggio competitivo attuale e dell’andamento del mercato e della concorrenza (in pratica capisco se il mio piano è coerente con l’evoluzione della realtà). Dato un piano strategico di 3-5 anni, si passa alla programmazione, ossia alla definizione (più analitica) del budget, vale a dire delle attività da svolgere nel prossimo anno. In questa fase è possibile ripartire i vari costi e ricavi per ogni divisione e funzione: avrò quindi il budget della divisione A, della divisione B… (budget divisionale) e il budget della funzione A, della funzione B… (budget funzionale), che insieme daranno il budget annuale dell’intera società. Sia la pianificazione sia la programmazione del budget devono essere discusse presso il Consiglio d’Amministrazione, dove i vari manager che hanno raccolto queste attività si confrontano con i membri del Consiglio. Nello specifico, ogni 6 mesi occorre riportare in Consiglio d’Amministrazione le analisi dell’andamento di gestione e delle cause degli eventuali scostamenti (e delle azioni da intraprendere per mitigarli). Questo approccio permette di ridurre i rischi dell’impresa, ed è il tema centrale della gestione, ai fini di ottenere una buona performance. GLOBALIZZAZIONE “Sembra che il grandissimo progresso della capacità produttiva del lavoro e la maggiore abilità, destrezza e avvedutezza con le quali esso è ovunque diretto o impiegato siano stati effetti della divisione del lavoro.” —Adam Smith (1776) La globalizzazione è stata determinata da due gruppi di fattori: quelli politico-istituzionali (nascita di organizzazioni internazionali come UE, ONU, WTO, OCSE, che hanno permesso una maggiore integrazione delle economie), e quelli tecnologici (Internet, cellulari, nuovi mezzi di trasporto… in grado di ridurre notevolmente le distanze spaziali e temporali). Va osservato che la globalizzazione di oggi non corrisponde alla globalizzazione della seconda metà dell’Ottocento, che era invece caratterizzata dalla circolazione di prodotti finiti e dal libero scambio, ossia dalla completa eliminazione dei dazi e di tutte quelle misure che ostacolavano gli scambi. A partire dalla Prima guerra mondiale iniziò un periodo di guerre 41 commerciali in cui i diversi paesi cercavano di promuovere le proprie esportazioni e di ridurre al minimo le importazioni provenienti dall’estero attraverso l’imposizione di dazi e politiche doganali (es. tariffa Smoot-Hawley del 1930). Tuttavia, dal Secondo dopoguerra gli USA decisero di invertire questa tendenza, senza però tornare al liberoscambismo precedente: furono firmati diversi trattati multilaterali come il GATT (1947) che portarono a una netta riduzione dei dazi, fino ad arrivare al WTO nel 1994. I paesi aderenti a quest’ultima organizzazione devono richiedere e ottenere l’autorizzazione se vogliono imporre dazi nei confronti di un bene prodotto da un determinato Paese. La caduta del Muro di Berlino nel 1989 ha poi comportato l’ingresso sulla scena economica mondiale di nuovi attori, come i Paesi dell’ex blocco sovietico e, successivamente, la Cina. Questo processo ha diminuito il numero di persone che vivono in condizioni di povertà estrema, soprattutto nei paesi asiatici: sicuramente la Cina ha tratto i maggiori benefici dalla nuova globalizzazione, con un tasso di povertà che è sceso dal 70% del 1984 al 10% del 2008. Inoltre, negli USA una serie di persone (es. donne o persone di colore) hanno iniziato a offrire il proprio lavoro in determinate mansioni che prima erano loro precluse. Queste persone, a causa della loro scarsa esperienza, erano disposte a ricevere salari inferiori rispetto a coloro che svolgevano tali mestieri da tempo. Lo stesso fenomeno si è verificato su scala internazionale, determinando veri e propri conflitti produttivi e distributivi: l’apertura degli stabilimenti nei paesi poveri, dove la manodopera costa meno, chiaramente ha generato malcontento e disagi presso gli operai dei paesi occidentali. Bisogna però tener presente che la dinamica salariale non è l’unica ragione per cui un’impresa decide di trasferire o meno la propria sede: smontare e ricreare una linea di produzione richiede tempo e capitali (per il trasferimento dei macchinari, la costruzione di nuovi stabilimenti e la formazione di nuovi operai); in aggiunta, le imprese devono anche considerare i vari sistemi giuridici in vigore. Alcune delle conseguenze della globalizzazione sono: La crescente divisione internazionale del lavoro. Adam Smith sottolinea come la divisione internazionale del lavoro, che all’inizio del Novecento diede origine alla catena di montaggio, fu un elemento essenziale per aumentare la produttività. NB: la catena di montaggio non presuppone necessariamente la prossimità fisica delle persone, basta pensare al caso del telelavoro, che consiste nel fornire regolarmente 42 una prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro (lavoro a distanza) avvalendosi del supporto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (es. quando un giornalista scrive un articolo per un quotidiano, non deve necessariamente essere presente fisicamente nella sede di quel quotidiano). Oggi non esiste un Paese senza divisione del lavoro. Una maggiore divisione del lavoro permette maggiori transazioni anche al di fuori del perimetro di un singolo paese. Minori costi di transazione. Con questo termine si indicano tutte le spese necessarie per perfezionare una transazione; perciò, sono inclusi non solo i trasferimenti di risorse (denaro) dall’acquirente al venditore, ma anche le informazioni legate al prodotto o di carattere legale. Quando decido di comprare un bene o di firmare un contratto relativo a un servizio (e di entrare in una relazione di scambio con qualcuno) devo anzitutto assicurarmi che quel bene/servizio esista e che esso sia in grado di soddisfare adeguatamente un mio bisogno. Se poi mi avvalgo di siti come Amazon, leggerò prima le recensioni e chiederò eventualmente consigli a chi possiede già quel bene; inoltre dovrò essere sicuro che quel bene sia in regola, che appartenga effettivamente al venditore e che quest’ultimo sia una persona affidabile in possesso dei diritti relativi alla vendita di quel prodotto. L’affidabilità del venditore viene garantita negli stati attraverso un insieme di norme che ci permettono di fidarci di persone estranee (limitatamente alle transazioni), poiché queste possono eventualmente essere citate in tribunale. In assenza di tali norme la quantità di scambi sarebbe assai inferiore, a causa di un costo di fiducia decisamente troppo elevato (= la mancanza di fiducia nei confronti di un venditore quasi sempre ci dissuade dal portare a termine una transazione). In generale, più è impegnativo l’acquisto legato a un bene durevole, maggiori saranno i costi informativi che saremo disposti a sostenere, nel senso che tenderemo a informarci maggiormente sulle caratteristiche dei prodotti più costosi o che utilizziamo di più (es. un PC). È ovvio che a fronte di costi di transazione elevati si riduce la probabilità che avvengano gli scambi. Maggiori innovazioni tecnologiche. Maggiore partecipazione di imprese e persone di diversi Paesi agli scambi. Una causa di ciò è che i beni e i servizi scambiati attualmente sono molto più complessi rispetto alla prima globalizzazione dell’Ottocento: spesso, pertanto, le imprese si scambiano fattori produttivi intermedi piuttosto che prodotti finiti. Ne deriva che anche gli oggetti apparentemente semplici che compriamo sono il risultato di un incrocio di sforzi e di materie prime che provengono da paesi diversi. Il tipico esempio è quello della Barbie, che è il risultato di una catena di montaggio che ha coinvolto vari paesi: i capelli di nylon vengono realizzati in Giappone; il cotone dei vestiti proviene dalla Cina; l’assemblaggio avviene in Indonesia; la California si occupa del design e della diffusione del prodotto. Un’infrastruttura giuridica assai più complessa: l’attuale struttura giuridica della globalizzazione non implica solo la promessa di non interferenza da parte di un altro paese. Questo a causa di due fenomeni: la maggiore complessità dei beni scambiati e dei trattati delle organizzazioni internazionali, che hanno lo scopo di armonizzare le condizioni produttive dei diversi paesi (es. garantire la tutela della proprietà intellettuale anche da parte dei paesi non occidentali, che hanno 43 un’infrastruttura amministrativa più debole). Basti pensare che il trattato del NAFTA (l’accordo commerciale che crea un’area comune di scambio tra USA, Canada e Messico) comprende circa 1700 pagine, mentre nell’Ottocento i trattati erano lunghi circa 10 pagine. PERCHÉ IL COMMERCIO E LA GLOBALIZZAZIONE ARRICCHISCONO? Il motivo principale è che con l’abbassamento dei costi di transazione e il miglioramento dei trasporti è aumentata la disponibilità di beni/servizi per i consumatori, mentre i venditori hanno avuto la possibilità di accedere ai mercati esteri e di differenziare i loro prodotti, introducendo anche delle innovazioni. Per esempio, fino a 15 anni fa il consumo di birra era indistinto e la bevanda era monopolizzata da pochi grandi marchi internazionali; attualmente, la situazione si è invertita: l’offerta di birra è più diversificata rispetto a prima perché è cambiata la percezione dei consumatori, che hanno iniziato a concepirla come sostituta del vino; in aggiunta, si sono abbassati i costi di trasporto, ampliando così la platea di paesi potenzialmente acquirenti. Una conseguenza di quest’ultimo fattore è che i produttori hanno iniziato a chiedersi quale particolare raffinamento di un prodotto prima standardizzato avrebbe successo presso un target specifico: questo è il motivo per cui oggi prodotti diffusi in tutto il mondo presentano peculiarità diverse in base al paese in cui ci troviamo (es. McDonald o Nescafé). L’aumento della platea di consumatori ha anche provocato un cambiamento dei beni/servizi che vengono prodotti, a causa della maggiore varietà di bisogni da soddisfare: mentre in società ristrette e chiuse il pastore rappresenta uno dei pochi fattori della produzione di beni/servizi, in società più ampie e aperte, con una maggiore divisione del lavoro, esistono mestieri come la dog-sitter, che libera tempo per i clienti. Sotto questo aspetto, la globalizzazione va di pari passo con il processo di urbanizzazione: la maggiore varietà di opportunità su cui costruire il proprio reddito (e quindi di servizi offerti) dipende dalla concentrazione di individui in grandi agglomerati urbani, il che aumenta la gamma di bisogni e di esigenze da soddisfare e, pertanto, la platea di possibili acquirenti. L’aumento della divisione del lavoro, dunque, porta a una crescente differenziazione dei beni proposti: mentre in una società chiusa e ristretta meno persone partecipano al gioco economico e solo pochi bisogni vanno soddisfatti, in una società aperta e urbana, con una maggiore divisione del lavoro, più persone partecipano al processo di produzione e consumo, aumentando così le esigenze da soddisfare. Ecco perché oggi esistono mestieri (come la dog-sitter) che erano inimmaginabili solo 50 anni fa. 44 L’apertura allo scambio internazionale ha modificato l’organizzazione del comparto produttivo dei singoli paesi, provocando miracoli o disastri. Nel 1900 molti paesi avevano un PIL pro capite tra i 1000 e i 5000 dollari; alcuni, come gli USA, il Giappone e la Corea del Sud, hanno raggiunto anche i 20000 dollari pro capite nel Secondo dopoguerra, mentre altri, come l’Argentina o la Nigeria, non sono cresciuti. Diversi fattori spiegano questo fenomeno, a partire dalla disponibilità di mercati (= il fatto che le produzioni di un certo paese trovassero sbocchi a livello internazionale) e da un interventismo non eccessivo dei governi e delle istituzioni. ALL’INTERNO DELLE IMPRESE Per capire cosa accade dentro un’impresa spesso si utilizza il modello* della catena del valore: si tratta di uno schema teorico fondato sulla suddivisione arbitraria delle sue attività. In base a tale modello, nelle imprese ci sono attività primarie, connesse alla creazione fisica del prodotto e alla sua consegna ai compratori, e attività secondarie (o di supporto). Nel primo gruppo rientrano la logistica in entrata (che assicura una gestione, un’organizzazione e uno stoccaggio adeguati dei flussi di risorse in entrata), la produzione, la logistica in uscita, il marketing e le vendite, e l’assistenza post-vendita. Tra le attività secondarie, invece, troviamo gli approvvigionamenti, la ricerca e lo sviluppo, la gestione delle risorse umane, e le infrastrutture e i trasporti. Un’impresa presente in più stati potrà organizzare queste attività in modi differenti, decidendo, ad esempio, su quale fetta del mercato concentrarsi, dove collocare una certa attività, oppure dove investire su macchinari all’avanguardia (in base all’efficienza del sistema giuridico locale: è meglio dotarsi di macchinari innovativi nei paesi in cui la legge impedisce ad altre imprese di copiarli, dove gli avvocati sono più affidabili e competenti…). *Generalmente un modello è una rappresentazione sintetica e semplificata della realtà, che ne coglie solo alcuni tratti; per esempio, la mappa della metro di Milano riporta solo i nomi delle fermate, ma non ci restituisce un’immagine satellitare e fedele della città. La globalizzazione ha reso più facile approvvigionarsi di materie prime o di semilavorati provenienti dall’estero, e ha agevolato il trasferimento all’estero (nei paesi emergenti) dell’attività produttiva (le “braccia”), ma anche della ricerca e sviluppo (le “menti” delle produzioni: es. oggi molti ingegneri provengono dall’India); è anche più facile cercare 45 capitali in altri paesi, grazie all’aumento della mobilità dei capitali garantito dalle varie innovazioni tecnologiche. LA GLOBALIZZAZIONE DAL PUNTO DI VISTA DELLE IMPRESE Grafico: quali ragioni spingono un’impresa a “globalizzarsi”? Un’impresa non può mai prescindere dalle persone che vi sono collegate, né tantomeno dal modo in cui vengono coordinate; di fatto, essa potrebbe essere vista come un insieme di contratti che garantiscono un rapporto di coordinamento stabile (= duraturo) tra i membri. Va sottolineato che la mobilità di beni e quella di persone vanno di pari passo: a partire dalla prima globalizzazione, i Paesi avevano iniziato a scambiarsi beni con maggiori libertà (= dazi più bassi) e maggior frequenza; questo comportò anche un grande spostamento di persone. Il grande vantaggio derivante da questa mobilità è che determinate produzioni si sono concentrate in determinati Paesi, nel senso che i vari stati si sono specializzati nella realizzazione di determinati prodotti, in base a dove tali prodotti possono essere ottenuti alle condizioni migliori (persone, climi, materie prime, esperienza… in questo modo, le risorse vengono teoricamente allocate nel miglior modo possibile). L’internazionalizzazione, dunque, può riguardare sia i prodotti finiti sia i capitali e le risorse a disposizione delle imprese. Importanti per le imprese transnazionali sono gli investimenti diretti esteri, ossia i flussi di investimenti indirizzati a paesi diversi da quello dove è insediato il centro della loro attività. Tali investimenti consistono, per esempio, nell’apertura di nuove strutture produttive locali o di filiali (greenfield: realizzazione di strutture ex novo) o nell’acquisizione di aziende o di catene già presenti e che magari stavano fallendo (brownfield: si subentra in aree e strutture produttive già esistenti, che vengono riconvertite); esiste anche un modo meno aggressivo per fare un’acquisizione, ovvero la “gestione integrata”, che consiste nel comprare le partecipazioni di un’impresa già esistente, oppure comprare una catena distributiva di successo (es. una 46 catena di birrerie) e aggiungervi un prodotto meno popolare (es. una tipologia di pizza). Essere presenti in più mercati aumenta il valore della propria azienda perché aumenta la base di domanda (clienti) che si possono soddisfare con i propri prodotti. Non è detto, però, che le strategie giuste di oggi fossero giuste anche in passato e saranno giuste anche in futuro: questa discontinuità può essere dovuta ai miglioramenti per quanto riguarda la tecnologia oppure i prodotti offerti dalla concorrenza. Il caso più classico è quello del cellulare Blackberry, che era dotato di una tastiera esterna completa, certamente più comoda dell’allora diffusa tastiera T9; tuttavia, l’invenzione dei cellulari con le tastiere touch hanno reso obsoleto quello che era stato il vantaggio che aveva contribuito al successo dei Blackberry. Lo stesso vale per le vecchie Polaroid e per le librerie alla fine degli anni ‘90: in quel periodo, infatti, si pensava che le grandi catene di librerie avrebbero divorato le piccole librerie di quartiere, grazie al fatto che disponevano di un’offerta di libri decisamente maggiore (tant’è che le grandi librerie avevano intrapreso la costruzione di nuove sedi); in seguito, però, si è diffusa la possibilità di acquistare libri online e in formato digitale, rendendo così questa strategia di espansione (che era giusta in partenza) e i relativi costi un’autentica palla al piede. In tutti questi casi le imprese devono reinventarsi, adattandosi alle nuove tecnologie e ai nuovi gusti del mercato. PROBLEMI LEGATI ALLA DIVERSITÀ CULTURALE Ci sono dei casi in cui la diversità culturale può essere un problema per le aziende che sono strutturate in diverse nazioni? Certamente esistono alcuni prodotti che sono legati alle tradizioni locali e all’identità di un paese e che, proprio per questo motivo, perderebbero il proprio significato se fossero trapiantati in un altro contesto. Un esempio è quello del vino, caratterizzato da una componente culturale fortissima: col tempo i consumi di vino sono diventati più raffinati, poiché si sono diffuse molte più informazioni sul prodotto, rendendo i consumatori più sensibili alle caratteristiche di una determinata tipologia di vino o semplicemente più curiosi di assaggiare vini prodotti in altri paesi. In aggiunta, negli ultimi 20 anni vari paesi in cui si consumavano maggiormente altri prodotti (es. birra) sono diventati al tempo stesso produttori e compratori di vino (es. USA hanno iniziato ad acquistare vino italiano): questo perché erano cambiate la cultura locale e la concezione del prodotto. È anche vero però che il fatto che un prodotto faccia parte dell’identità di un paese può trasformarsi in un vantaggio, attribuendogli un’aura di autenticità che gli permette di avere successo anche all’estero (es. vino piemontese o siciliano). La diversità culturale è una sfida pure dal punto di vista burocratico ed etico: se si vuole produrre qualcosa per un certo mercato bisogna anzitutto avere un’ipotesi su ciò che i consumatori potrebbero desiderare, ricordando che la cultura e i consumi cambiano nel corso degli anni (es. non avrebbe senso vendere prodotti di make-up nei paesi in cui le donne sono costrette a portare il velo). Ne deriva è importante avere del personale che conosca la cultura e la legge di un certo territorio: ovviamente, per ottenere il permesso di poter produrre in determinati paesi bisogna assicurarsi che le proprie attività siano conformi al dettato della legge locale. 47 Grafico: indica la percentuale di TNC (transnational corporations, ossia imprese transnazionali) presenti nei Paesi sviluppati (in nero) e nei Paesi in via di sviluppo (in bianco). Gli investimenti provenienti dall’estero sono un riconoscimento che un certo paese rappresenta un mercato interessante con buone condizioni legali e/o un basso livello di concorrenza per quanto riguarda un certo prodotto. La quantità di investimenti di un’impresa in altri paesi dipende dalle dinamiche di crescita e di sviluppo sia del suo paese d’origine sia del paese estero: se un’impresa opera in un mercato povero e fatica a svilupparsi, difficilmente si porrà il problema di avvicinare quote di consumatori internazionali. Se invece l’economia di un paese cresce (come sta avvenendo per alcuni paesi in via di sviluppo), anche le sue aziende possono integrarsi nell’economia globale. Dunque non è vero che solo i grandi gruppi occidentali si sono internazionalizzati; esistono anche imprese provenienti da paesi ex poveri o da economie ancora oggi in via di sviluppo che si stanno internazionalizzando, per esempio la Samsung della Corea del Sud o la Huawei cinese. Esse rappresentano un segnale del fatto che alcuni paesi hanno iniziato a investire sullo sviluppo di idee innovative in ambito tecnologico, il che ha anche permesso a tali imprese di attrarre investimenti provenienti dall’estero (prima invece si riteneva che la Cina non fosse in grado di produrre idee nuove, a causa della forte regolamentazione del mercato delle idee e delle università). LE CARATTERISTICHE CHE RENDONO UN TERRITORIO ATTRAENTE 48 Tra le principali ragioni troviamo un minore costo della manodopera, un minor carico burocratico-regolamentare e la possibilità di accedere a nuovi mercati e di sviluppare nuovi prodotti (adattandoli alle condizioni e ai gusti locali), ampliando così la gamma di consumatori. Quanto alle risorse umane, il costo del lavoro non è necessariamente l’elemento predominante: se decido di fare un investimento produttivo in un altro paese (es. per aprire uno stabilimento), devo anzitutto trovare dei finanziamenti (es. presentando alle banche un’idea interessante che faccia presagire che i loro soldi torneranno indietro con gli interessi), ma poi devo anche ottenere i vari permessi, trovare gli spazi adeguati per svolgere la mia attività e trasferire/realizzare i miei macchinari, operazione assai costosa (nel caso delle imprese automobilistiche, un macchinario è in grado di produrre solo un determinato tipo di automobile). Dovrò infine assicurarmi che la legge di quel paese protegga la mia attività, impedendo 49 per esempio ai ladri di entrare nel mio stabilimento e di distruggere i miei macchinari. Sono poi fondamentali le infrastrutture, per allocare in modo migliore i fattori produttivi (es. quando devo spostare i fattori produttivi intermedi verso il paese in cui commercializzerò il bene finito), come anche l’istruzione e le infrastrutture per la ricerca e l’innovazione, al fine di garantire che la forza lavoro venga formata in modo adeguato. Anche il tessuto economico è importante, poiché bisogna tener conto del funzionamento del sistema finanziario e della distribuzione: se produco un bene di consumo e voglio far sì che arrivi alle case delle persone, è importante che la distribuzione sia efficiente (es. quando Amazon è arrivata in Italia, inizialmente le merci venivano recapitate via corriere, a causa della cattiva reputazione che avevano le nostre poste; ora, invece, anche queste ultime possono consegnarle). In questa categoria rientra anche la struttura del sistema industriale locale: se produco automobili posso certamente far arrivare alcuni componenti da altri paesi, ma altri dovrò acquistarli in loco per ragioni economiche; di conseguenza, prima di investire in un determinato paese controllerò anche il numero di produttori e fornitori locali delle componenti che mi servono. Le istituzioni e le politiche pubbliche (es. regolamentazioni oppure leggi amministrative, fiscali e contrattuali): il costo del lavoro non dipende solo da quanto viene pagata la forza lavoro, ma anche dalle imposte e dai contributi sociali; pertanto, la struttura del welfare state e della tassazione locale possono far variare il costo del lavoro e convincere o meno un’impresa a investire all’estero. Anche un interventismo eccessivo da parte delle istituzioni nazionali non rappresenta di certo un incentivo per le imprese che vogliono investire in un determinato paese (es. se in un Paese non viene rispettato il diritto di proprietà, oppure se il governo nazionalizza le imprese a capitale estero o impone loro i componenti del Consiglio d’Amministrazione). La presenza di politiche ad hoc per l’attrazione di investimenti esteri (es. sgravi fiscali, sussidi mirati o permessi speciali per ristrutturare un sito produttivo) non è sempre tenuta in grande considerazione dalle imprese, in quanto tali norme spesso sono temporanee. Va anche tenuto presente il seguente fattore: è vero che una norma vantaggiosa per gli investitori esteri non danneggia necessariamente le imprese nazionali (es. incentivi alla produttività o minore tassazione); tuttavia, nel caso esista una norma a favore solo delle imprese a capitale estero, significa che il paese non ha le risorse o la forza politica necessarie per fare un’analoga riforma a beneficio di tutti, e questo chiaramente è un campanello d’allarme per le imprese estere. Le leggi nella sfera ambientale e i regolamenti settoriali: una normativa sull’ambiente tutela certamente l’ecosistema, ma può incrementare i costi di produzione. La qualità sociale e ambientale: come già detto, le imprese difficilmente investono nei paesi con un alto tasso di criminalità. NB: se voglio attrarre nuovi manager locali dopo aver fatto un investimento significativo in un paese in via di sviluppo, devo inviare i miei manager migliori, ma per assicurarmi la loro fedeltà 50 dovrò evitare di trasferirli in paesi poco sicuri. Un’impresa deve anche tenere conto dei gusti dei consumatori locali, che dipendono dalle loro abitudini culturali e dal loro grado d’istruzione (es. non aprirò una libreria in un paese dove la gente legge poco). La reputazione del luogo, che ovviamente influenzerà il mio rapporto con altri investitori/finanziatori. LA TENDENZA ALL’EQUILIBRIO E IL TRASFERIMENTO DELLA CONOSCENZA “Un lutto pubblico fa salire il prezzo della stoffa nera e aumenta il profitto dei mercanti che ne posseggono una quantità considerevole. Esso non influenza i salari dei tessitori. Il mercato scarseggia di merci, non di manodopera: di lavoro fatto, non di lavoro da fare. Esso aumenta i salari dei sarti, il cui mercato scarseggia di manodopera. Qui la domanda effettiva di manodopera e di lavoro da fare è maggiore di quella disponibile. Essa diminuisce il prezzo delle sete e delle stoffe colorate, riducendo conseguentemente i prodotti dei mercanti che ne detengono quantità considerevoli. Riduce pure i salari dei lavoratori occupati nella confezione di merci la cui domanda è ferma per sei mesi o forse un anno. Il mercato è qui [nel caso delle stoffe colorate] provvisto in eccesso di merce e di manodopera”. – Adam Smith In generale, nei mercati c’è sempre una tendenza all’equilibrio, e i prezzi di una merce ne segnalano la quantità domandata. Nel caso di questa citazione, il lutto pubblico aumenta il lavoro dei sarti, che devono trasformare la stoffa nera in un vestito, e riduce le vendite e i prezzi delle stoffe colorate. L’aumento dei prezzi serve a rendere disponibili pezzi di stoffa nera, ovvero a pagare i sarti che la lavorano e la trasformano in vestiti adatti al lutto; la riduzione dei prezzi delle stoffe colorate, invece, serve a convincerci che, nonostante il momento di lutto, possiamo anche comprare vestiti colorati. In altre parole, i prezzi sia nazionali sia internazionali non esistono isolati e in astratto, ma dipendono da altri fattori produttivi e altri beni. Uno dei maggiori vantaggi dell’internazionalizzazione è il trasferimento della conoscenza: se un’impresa si sposta in un altro Paese, gli operai del posto hanno l’opportunità di imparare a fare cose che in precedenza non sapevano fare (perché gli operai “esperti” insegneranno loro come far funzionare un determinato macchinario, ad esempio). Esistono anche altri modi di condivisione della conoscenza, come il cosiddetto learning by observing, ossia l’imitazione, che consiste nell’imparare copiando la tecnica e il metodo degli altri (per esempio le imprese concorrenti); esiste anche l’outsourcing, cioè il procedimento in base al quale, una volta trovati dei fornitori locali che siano bravi a realizzare una certa componente, si insegna loro come realizzarla seguendo gli standard che ci servono; infine ci sono gli spostamenti di capitale umano: un’impresa invia i suoi manager per trasmettere le proprie conoscenze ai manager locali. Un paese deve curare la propria reputazione e cercare di risultare attraente per le imprese. Per farlo vengono applicate strategie politiche (es. riduzione delle imposte) oppure il cosiddetto “marketing territoriale”, volto a promuovere i prodotti e l’immagine del proprio territorio all’estero, per esempio tramite l’invio di rappresentanti o società (es. la regione Campania aveva aperto un ufficio di rappresentanza sulla Fifth Avenue di New 51 York). Tale strategia deve essere basata sulla coerenza, la continuità e la collaborazione tra pubblico e privato (l’ufficio della regione Campania chiuse perché vendeva prodotti “made in Campania”, non “made in Italy”), e le autorità del Paese di provenienza devono essere concordi sui suoi punti di forza, altrimenti la reputazione ne risentirebbe. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PICCOLE IMPRESE Il mercato internazionale non è fatto solo per le grandi imprese (= aziende che hanno più di 250 dipendenti), che in Italia costituiscono solo lo 0,1% del totale delle imprese. D’altro canto, un’alta concentrazione di piccole imprese (che rappresentano il 90% delle aziende di tutto il mondo) può anche rovinare la reputazione di un paese, poiché è un segnale che quest’ultimo è pieno di imprese nuove appena formatesi, oppure di imprese che hanno a disposizione pochi capitali a causa di difficoltà relative al sistema burocratico e finanziario (es. problemi ad accedere al sistema bancario), oppure a causa del tipo di beni che producono (se sono beni costosi o adatti solo a una fetta specifica di mercato), o ancora per la presenza di fattori esterni che hanno persuaso i manager a mantenere dimensioni ridotte e pochi dipendenti (es. la tassazione progressiva oppure un mercato del lavoro troppo rigido, vedi articolo 18 in Italia). Una ragione storica per cui la maggior parte delle imprese italiane sono piccole è che verso la fine degli anni ’50 l’Italia decise di favorire le grandi industrie pesanti nel Nord e di costruire stabilimenti e stanziare capitali nel Sud, in modo da garantire lo sviluppo industriale anche nel Meridione e colmare così il divario di reddito (l’idea era che mettendo più fabbriche nel Sud sarebbe cresciuta la produttività dei lavoratori, colmando il gap). Il problema fu che, nonostante queste aspettative, non si diffusero le grandi imprese come previsto, bensì si preferì trasformare le varie botteghe artigianali in piccole imprese, in modo da mantenerne il pieno possesso e controllo (il risultato sono i capannoni che vediamo ancora oggi nel Nord). Sfortunatamente, una struttura fatta di piccole imprese non internazionalizzate è più permeabile agli shock economici. Un dato interessante è che, mentre il numero medio di addetti in un’impresa italiana è di circa 3,7, la dimensione media delle imprese estere controllate da aziende italiane (dette controllate estere) supera gli 80 dipendenti. Questo significa che non è vero che gli italiani non sanno gestire dimensioni superiori, ma che una delle ragioni per cui investono all’estero è che cercano e sperano di trovare ambienti più favorevoli alla crescita dimensionale. I MICRO-BIRRIFICI Rispetto al vino, la birra è più facile, più veloce e meno costosa da produrre autonomamente (per realizzare il vino servono grandi vigne e ci vogliono mesi o persino anni, mentre per la birra bastano 2-3 settimane); per questo motivo è più facile entrare nel mercato della birra: ci sono imprese che producono anche meno di 20.000 barili all’anno (e che classifichiamo come micro-birrifici). In questo ambito, la piccola dimensione permette una maggiore differenziazione e sperimentazione del prodotto, mentre le grandi dimensioni obbligano a rispettare determinati standard fissi (es. sapore) che rendano il prodotto riconoscibile nei diversi paesi in cui viene distribuito, senza creare problemi con le 52 norme di sicurezza locali. Questo è il motivo per cui i micro-birrifici godono di indipendenza legale ed economica dai grandi birrifici internazionali. Negli USA c’erano tantissimi produttori di birra all’inizio del Novecento, poiché produrre la birra era un’attività artigianale che riguardava i mercati locali. Il numero di produttori crollò con la diffusione del proibizionismo (1920-1933), periodo in cui venne limitata l’offerta di qualsiasi tipo di alcol; per massimizzare le vendite clandestine delle modeste quantità di alcol presenti, si iniziò ad allungare l’alcol con altri prodotti, dando il via alla grande stagione dei cocktail. Dal 1936 i produttori di birra escono dalla clandestinità: fino al 1979 solo le grandi aziende producono birra, e tendono man mano a fondersi le une con le altre (quindi il numero complessivo di produttori di birra diminuisce). Ciò a causa della sempre più rigida regolamentazione della produzione di birra, con norme pervasive che rendevano assai costoso il processo, a beneficio dei grandi produttori (= erano aumentati i costi di gestione legati alla burocrazia, costi che erano più abbordabili se ci si riuniva in grandi imprese). A partire dal 1979 Carter allenta le norme che governano la produzione di birra; di conseguenza sono aumentati i piccoli produttori, tanto che nel 2012 le piccole birrerie erano circa 2000, e nel 2017 erano più di 6000, contro le 89 del 1979 (sono più concentrate sulle due coste a causa del reddito pro capite più elevato, che determina una maggiore curiosità e sofisticazione dei gusti). 53 Le esportazioni dei micro-birrifici sono aumentate in modo massiccio durante gli ultimi anni: nel 2013 sono stati esportati 282.526 barili, una cifra considerevole per un prodotto che si presenta come locale e indipendente, il che suggerisce che la birra non è più standardizzata come in passato (il Brasile è il mercato estero più in crescita). Tutto ciò è avvenuto nonostante il fatto che tutte le tipologie di birre (ma anche di vini) siano intercambiabili tra di loro, essendo accomunate dalla stessa funzione (le beviamo, non possiamo usarle come carburante!) e dallo stesso tempo necessario per consumarle. Eppure, ogni produttore ambisce a essere il monopolista di una determinata varietà di birra o vino che, a suo dire, è unica. Pertanto, l’internazionalizzazione ha contribuito a modificare la nostra percezione della birra: mentre prima la consideravamo un prodotto unico che doveva rispettare degli standard più o meno fissi, ora invece ci troviamo di fronte a moltissime tipologie diverse del medesimo prodotto. Un esempio di questi piccoli birrifici è il Flying Dog Brewery, un birrificio con sede nel Maryland, fondato da un astrofisico, che produce oltre 100.000 barili all’anno e ha appena lanciato una collaborazione internazionale con una birreria serba, chiamata Dogma, con la quale ha realizzato una nuova birra. Ciò rappresenta una forma di collaborazione internazionale tra imprese di diverse dimensioni (piccola quella del Maryland e microscopica quella serba) che hanno lavorato congiuntamente condividendo informazioni via mail (si tratta dunque di una modalità di collaborazione semplicissima). Una delle ragioni di questa collaborazione era che il birrificio del Maryland contava due importatori in Serbia sin dall’inizio della sua attività; ne deduciamo che un’impresa, per promuovere un prodotto, può trasferirlo e venderlo in un altro paese (e questo è già un modo di condividere la conoscenza), oppure trovare dei collaboratori locali. Pertanto, l’internazionalizzazione rappresenta un’opportunità sia per vendere sia per differenziare un prodotto anche nel caso delle imprese più ridotte. 4 TRATTI COMUNI DELLE PICCOLE IMPRESE DI SUCCESSO A LIVELLO INTERNAZIONALE 54 1) Qualità imprenditoriale: il piccolo imprenditore deve avere una forte e costante spinta propulsiva, ovvero deve essere audace e cercare costantemente di sviluppare l’azienda, senza mai arrendersi. Deve anche avere una buona memoria e saper gestire le varie opportunità e i vari mercati, senza trascurarne nessuno a priori o, peggio, sprecarli; a tal fine, il manager deve ricordare tutti gli obiettivi che sono stati stabiliti insieme al team, spronandolo continuamente a cercare di realizzarli (il rischio è che alcuni degli obiettivi prefissati vengano trascurati nel corso dell’anno aziendale). Il piccolo imprenditore deve poi fungere da perno relazionale, ovvero essere in grado di mantenere le relazioni coi propri clienti, con gli addetti alla riparazione dei macchinari, coi fornitori e così via; in poche parole, deve essere al centro delle reti di relazioni e, nel caso dell’espansione in nuovi mercati, deve saper sviluppare reti di fiducia con i nuovi fornitori e capire quanti e quali sono i concorrenti. Chiaramente serve una governance equilibrata e coesa, anche se spesso nelle piccole imprese si verificano vari problemi sotto questo punto di vista: è il caso, per esempio, delle piccole imprese a conduzione familiare, nelle quali, a causa dello scarso numero di soci presenti, si generano conflitti in merito alla distribuzione dell’eredità tra i figli del capofamiglia. 2) Sviluppo del capitale immateriale: come sostiene Gary Becker, “le forme tangibili di capitale non sono le sole. L’istruzione scolastica, un corso di formazione all’uso del computer, le spese per le cure mediche e le lezioni sulle virtù della 55 puntualità e dell’onestà sono del pari una forma di capitale, per il motivo che fanno aumentare le nostre entrate, migliorano la nostra salute o rafforzano le nostre buone abitudini nel corso della vita. Per tale motivo gli economisti considerano le spese a favore dell’istruzione, della salute e via dicendo come un investimento in capitale umano. Si parla di capitale umano perché gli individui non possono essere separati dalle loro conoscenze, dalle loro competenze, dalla loro salute o dai loro valori nello stesso modo in cui possono essere distinti dai loro beni finanziari e fisici.” Bisogna ricordare che il capitale è eterogeneo, in quanto può essere costituito da beni mobili e immobili, come denaro, brevetti, e risorse a disposizione, ma anche da beni immateriali, ossia il patrimonio di conoscenze a disposizione dell’azienda. Due caratteristiche che accomunano qualsiasi tipologia di capitale sono il guadagno (= il capitale deve fruttare) e il fatto che possa essere accumulato; alla luce della natura del capitale appena descritta, Gary Becker ha coniato la definizione di “capitale umano”, applicando il concetto di capitale al lavoro: anche il lavoro, infatti, è basato sull’accumulazione e produce un reddito. Secondo lo studioso, le spese a favore delle cure mediche o di un qualsiasi corso di formazione sono comunque un investimento in capitale umano, anzitutto perché, nel primo caso, se siamo malati siamo meno produttivi ed eventualmente non siamo in grado di recarci sul posto di lavoro; inoltre, tali spese ci permettono di accumulare una serie di fattori (competenze) che più avanti restituiranno un rendimento (del resto, il capitale umano non può essere separato dalle proprie competenze, salute o valori). Va aggiunto che una delle questioni più importanti nell’ambito dell’internazionalizzazione è la condivisione di tutto il patrimonio di conoscenze disponibili, a cui si affianca la reputazione dell’azienda: quest’ultima, infatti, deve essere eticamente responsabile e mantenere una buona immagine nel contesto in cui opera. Questo è il motivo per cui non è detto che un’azienda che bara ne tragga sempre dei vantaggi, a meno che il contesto in cui opera non cambi (altrimenti prima o poi verrà scoperta e la reputazione ne risentirà, intaccando i futuri rapporti con i nuovi fornitori o clienti). 3) Competizione focalizzata: nel momento in cui si internazionalizza, la piccola impresa dovrà focalizzarsi su una nicchia di mercato, ovvero su una singola e ben definita fascia del mercato. Questo perché se si dedicasse alla realizzazione di più tipologie di prodotti diversi non potrebbe tener testa alle grandi imprese, a causa dell’evidente svantaggio a livello di capitali (anche umani), capacità produttive e quantità di merce prodotta: grazie alle sue dimensioni, infatti, un’impresa grande è una sorta di conglomerato che può fare bene tante cose diverse. La piccola impresa, invece, deve concentrare le proprie risorse esigue su un singolo business: una volta che avrà acquisito una buona reputazione e si sarà “allenata” abbastanza nello svolgere un determinato tipo di attività, acquisendo esperienza, potrà allora tentare di uscire dai confini nazionali, instaurando partnership internazionali. 4) Capacità di innovazione: è collegata a quanto appena detto. L’innovazione è la conseguenza di una buona organizzazione dei processi: se realizzo costantemente un prodotto, rifletterò sul modo in cui lo sto producendo e introdurrò di volta in volta delle innovazioni, cercando di migliorarlo e di economizzare allo stesso tempo 56 gli sforzi e le spese (= produrre lo stesso utilizzando il minimo capitale possibile, in modo da ottimizzare le risorse a disposizione). LE ECONOMIE DI SCALA E LA DIMENSIONE DI UN’IMPRESA Normalmente se produco una quantità aggiuntiva di un singolo bene, il costo unitario aumenta; se però i vari membri del personale di un’impresa si specializzano ciascuno in una determinata fase del processo di produzione, allora il costo unitario diminuisce, anche a fronte di un aumento della quantità di beni prodotta (chiaramente quest’ultima deve essere coerente con la capacità di produzione del personale). Quindi l’economia di scala implica che aumentando la produzione si riesca parallelamente ad aumentare l’efficacia e la qualità del processo produttivo. Per un’impresa che cresce di dimensioni, oppure per due imprese che si fondono, è più facile migliorare l’efficienza del processo produttivo, in quanto aumenta il grado di divisione del lavoro (e la capacità di svolgere un’attività specifica), migliora la reputazione e, soprattutto, ci si può arrischiare a inventare nuovi prodotti: l’impresa più grande, infatti, può permettersi di sprecare tempo, lavoro e risorse nel caso in cui il prodotto risultante non avrà successo sul mercato, mentre quella piccola deve usare in maniera più consapevole e attenta le risorse scarse a disposizione. Tuttavia, esistono anche le diseconomie di scala: con l’aumento delle dimensioni (anche a livello internazionale) di un’impresa, aumentano le difficoltà relative al coordinamento delle attività, come anche i possibili problemi legali e i costi necessari per mettersi in regola rispetto a una nuova amministrazione fiscale (in pratica, se un’impresa è abituata alle condizioni di un determinato paese poi diventa difficile adattarsi a quelle di un altro). I VARI MODI DI INGRESSO NEL MERCATO INTERNAZIONALE E I BENEFICI DELLA SPECIALIZZAZIONE Se un’impresa decide di spostarsi in un mercato estero, dovrà modificare il grado di specializzazione e di divisione del lavoro interno/esterno, scegliendo se comprare su base stabile e duratura determinati servizi oppure se acquistarli volta per volta sul mercato. L’impresa è un insieme di rapporti giuridici contrattuali (nexus of contract) che vengono stipulati in modo diverso con persone diverse. In alcuni casi la produzione viene trasferita e avviene interamente all’interno dell’azienda, con un’organizzazione è orientata alla gerarchia (internalizzazione), mentre in altri casi si conferisce la produzione dei beni e dei servizi necessari a un’impresa esterna, senza poter influire sulla modalità con cui devono essere prodotti (esternalizzazione). Negli anni ‘70 andavano di moda i conglomerati, ossia grandi aziende in cui si concentravano imprese e divisioni che operavano in settori diversi, come la General Electric (si occupa di elettrodomestici, assicurazioni, lampadine, banche) oppure, ai giorni nostri, Google (ultimamente ha investito nelle energie alternative, uscendo quindi dai confini rappresentati dal settore dell’informatica e dei software). Una maggiore diversificazione della produzione comporta una serie di vantaggi che sono correlati anche all’internazionalizzazione (= investire in altri paesi): difatti, gestire settori diversi assomiglia a gestire mercati diversi, pertanto i conglomerati possiederanno un patrimonio di conoscenze gestionali che potranno poi 57 applicare anche per internazionalizzarsi (a partire dalle economie di esperienza: sbagliare e imparare dai propri errori). Esistono varie modalità di collaborazione e divisione del lavoro a livello internazionale: Lo scambio diretto tra Paesi, che può essere limitato da dazi, quote d’importazione (contingentamenti) o barriere regolatorie e parafiscali (sono meno chiare rispetto alle altre due: es. un paese che stabilisce vari standard che le merci devono rispettare per ragioni di sicurezza o ambientali, oppure per tutelare i produttori nazionali). In realtà, però, lo scambio diretto tra i governi di due paesi avviene solo in ambito aerospaziale e militare. Più frequenti sono: Lo scambio tra imprese e consumatori privati; Lo scambio all’interno delle imprese stesse: è il caso, per esempio, delle imprese che si dotano di una serie di unità di produzione in un certo paese. Esistono varie strategie per entrare in un mercato diverso da quello in cui è nata un’impresa: Commercializzare anche in un altro paese i prodotti che si vendono nel paese d’origine (esportazioni dirette). È certamente la modalità meno complessa dal punto di vista dell’organizzazione imprenditoriale, in quanto non comporta l’integrazione di un’altra realtà imprenditoriale; tuttavia, essa presenta comunque diversi problemi, a partire dal fatto che ogni mercato e ogni gruppo di consumatori differiscono, come anche le regole del gioco, le attitudini culturali e le disponibilità economiche. Va aggiunto che con questa modalità eventuali problemi riguarderanno solo me e la mia controparte doganale. Costruire o acquisire impianti produttivi nel nuovo paese per realizzare localmente i prodotti. Ne vale la pena se in un paese vi è un’elevata domanda dei prodotti della mia azienda, oppure per far diminuire i costi di trasporto, o ancora perché nel nuovo paese trovo fattori produttivi più adatti alle mie esigenze. Acquisire e sviluppare conoscenze. Un’impresa può decidere di aprire un’unità di ricerca e sviluppo in un nuovo Paese (perché ad esempio in quel Paese c’è una disponibilità crescente di ingegneri), oppure sviluppare una partnership con un’università o comprare un’impresa che contribuisce alla produzione della conoscenza; in questo modo acquisirà sia le conoscenze che tale impresa svilupperà sia quelle che possiede già, migliorando la propria capacità di sviluppare nuovi prodotti. Va sottolineato che non sempre maggiori dimensioni equivalgono a migliore ricerca e sviluppo, anche se certamente una grande impresa ha una maggiore disponibilità di capitale che permette una maggiore innovazione di prodotto. La strategia scelta dipende dal Paese in cui si vuole entrare ed eventualmente dal tipo di collaborazione che si vuole instaurare. Avere un partner o acquisire un’azienda a livello locale è sicuramente un punto di forza, perché questi conoscono meglio i gusti del mercato locale, i procedimenti burocratici locali e le varie regolamentazioni (es. come deve essere fatta l’etichetta, quali prezzi imporre per essere competitivi…). In aggiunta, un’alleanza con aziende estere consente di esportare più facilmente alcune tipologie di 58 beni o servizi, perché magari il prodotto della mia impresa si abbina bene con quello di un partner locale, oppure perché quest’ultimo realizza componenti complementari rispetto a quelli che produco io. NB: tutte le alleanze sono governate da un contratto che definisce diritti e doveri di ogni membro; esse possono rispondere a esigenze quali lo scambio di know-how, prodotti, capitali o tecnologie. Esiste anche una serie di fattori esterni non controllabili dalle imprese, in primis le innovazioni tecnologiche e il comportamento degli attori pubblici (es. stati) e della concorrenza, da cui però si può apprendere per imitazione; ovviamente è sempre possibile rivedere le proprie strategie in base all’operato dei concorrenti. Non va dimenticato, tra l’altro, che anche se detengo il monopolio di un prodotto, il consumatore può optare per dei beni surrogati (= simili ai miei, ma di qualità inferiore); in altre parole, possono essere miei concorrenti anche coloro che vendono prodotti surrogati rispetto ai miei. Impegno finanziario e impegno organizzativo vanno di pari passo, insieme al potenziale radicamento nel mercato estero. L’impegno organizzativo consiste essenzialmente nell’ottimizzare il tempo a disposizione delle risorse umane, che è la risorsa più scarsa che esista. NB: un elevato radicamento nel mercato estero (che significa essere più internazionalizzati) non è sempre un fattore positivo: certamente, un’impresa che si concentra su un singolo mercato dipenderà fortemente dalla domanda interna locale; allo stesso tempo, però, se un’impresa è profondamente integrata in un mercato estero, essa 59 dovrà affrontare un maggior numero di rischi e di timori, perché in caso di crisi finanziaria locale o di instabilità politica perderà buona parte del proprio reddito. Le esportazioni indirette (es. accordo consortile o presenza di un intermediario internazionale) richiedono un impegno limitato, ma dipendono dal sistema logistico e distributivo estero (al pari delle partnership estere), mentre quelle dirette richiedono la presenza di una rete commerciale, e quindi un impegno maggiore. LEZIONE DI RIEPILOGO La globalizzazione ha portato a un aumento del commercio internazionale e alla crescita del volume degli scambi a causa di due tipologie di fattori: fattori politici (dal 1945 si è verificata una crescente integrazione dei mercati internazionali, con lo sviluppo di accordi come il GATT) e fattori legati alla riduzione dei costi di transazione (es. migliori tecnologie, maggiore velocità nello scambio di informazioni tra le aziende, miglioramento, anche dal punto di vista della sicurezza, dei trasporti). Grazie alle innovazioni tecnologiche, infatti, si sono ridotti i costi legati alle transazioni (costi informativi, di trasporto, comunicazione) ed è aumentato così il numero delle stesse. La “transnazionalizzazione” dell’impresa comporta non solo gli scambi di beni e merci, ma anche l’integrazione delle catene che portano alla produzione di un bene (es. iPhone è disegnato e commercializzato negli USA, ma le componenti vengono realizzate in 8-9 paesi diversi; dal punto di vista statunitense è sia un’esportazione sia un’importazione). Più aumenta e diventa complicata la divisione internazionale del lavoro, più le imprese di diversi paesi si specializzeranno in una sola fase del processo produttivo di un bene, e maggiore sarà l’integrazione tra le varie catene (integrazione che sarà sempre più minuziosa e verticale). L’integrazione può avvenire tra aziende e tra imprese diverse che rimangono separate, oppure tra aziende che diventano unità produttive della stessa impresa. L’indice per capire quanto un Paese è integrato nell’economia globale (e quanto è attraente) sono gli investimenti diretti esteri, che possono essere greenfield o brownfield. Vi sono varie ragioni per cui ci si globalizza: bassi costi di produzione, ricerca di nuovi mercati i cui membri siano disposti a spendere soldi per acquistare i miei prodotti, infrastrutture, condivisione di know-how e di informazioni, minori restrizioni burocratiche, qualità delle istituzioni (es. presenza di politiche per l’attrazione), e così via. A volte il medesimo accadimento può essere interpretato in modo diverso dagli investitori internazionali, come nel caso recente di Telecom, a seguito del quale per alcuni investitori l’Italia è risultata un Paese in cui non puoi acquisire il controllo di un’azienda se non sei d’accordo col governo, mentre per altri investitori l’Italia è apparsa come l’unico paese europeo in cui coloro che detengono i fondi di minoranza (passivi rispetto alla governance dell’azienda, nel senso che non influiscono sulle decisioni) possono organizzarsi e contendere l’azienda all’azionista di maggioranza. Tendenza all’equilibrio: spesso si parla di innovazioni disruptive (= che tendono a sconvolgere lo scenario competitivo, es. Uber nel settore automobilistico), però nei mercati internazionali c’è sempre una tendenza all’equilibrio, nel senso che i fattori produttivi tendono a ricombinarsi affinché possano essere allocati e utilizzati nel modo più profittevole (l’uso migliore per un fattore produttivo è quello che rende di più e per il quale 60 c’è una domanda maggiore: per esempio, il rame può essere utilizzato per realizzare cavi o padelle, a seconda di quale di questi prodotti sia più richiesto in un determinato momento). La riallocazione dei fattori produttivi, però, avviene raramente in modo lineare. Problemi e opportunità per un’impresa che si internazionalizza: cercare mercati equivale a cercare nuovi consumatori oppure fornitori che ci vendano prodotti che ci rendano più competitivi. Quanto alla ricerca e sviluppo, le imprese cercano contesti in cui le risorse umane siano di qualità: questo significa che la forza lavoro non deve sbagliare ad azionare le macchine o a realizzare i pezzi (altrimenti aggraverebbe la situazione dell’azienda, aumentando gli oneri finanziari), non deve ammalarsi spesso e deve essere affidabile e onesta. Del resto, sarebbe dannoso per un’impresa se le proprie risorse umane sottrassero documenti riservati e prodotti, se lasciassero lo stabilimento dopo aver timbrato il cartellino, o se fossero sempre assenti (NB: non in tutte le culture esiste l’aspirazione a fare bene il proprio lavoro). Tutto ciò rientra nella gestione internazionale del capitale umano. Va ricordato che l’internazionalizzazione è un processo graduale, non istantaneo: scelgo di investire in un territorio, investo, infine mi adeguo a quel territorio (assestamento, sviluppo). La velocità di tale processo dipende ovviamente dal tipo di bene che produco, dal tipo di investimento che voglio fare (brownfield o greenfield; aprire un nuovo impianto produttivo richiede più tempo, anche se riconvertirne uno già esistente non è sempre la scelta più pratica: se passo dal fare sigarette a fare medicine è più comodo realizzare una nuova fabbrica) e dai beni immateriali che ho a disposizione. Il vantaggio competitivo: è la capacità dell’impresa di superare gli avversari nel raggiungimento del suo obiettivo primario, vale a dire la redditività. Le due questioni cruciali, che sono le più difficili da bilanciare, sono le dimensioni della mia impresa e la specificità del mio prodotto (= rendere il mio prodotto unico e standardizzato vs adeguarlo a diverse culture, sfruttando però i vantaggi derivanti dalle maggiori dimensioni). SEMINARIO: ORO – SALVATORE ROSSI LA POLITICA DELLA MONETA In italiano il concetto economico di mezzo di pagamento caratteristico della compravendita viene espresso con tre parole diverse: denaro (la più comune, che verrà utilizzata in questo paragrafo con tale accezione), moneta e soldi. Tuttavia, il termine più adeguato dal punto di vista economico è “moneta”, che indica anche il dischetto di metallo coniato dagli stati. In inglese invece si dice solo “coin” per indicare la moneta. “La moneta non è, propriamente parlando, uno degli oggetti del commercio ma soltanto lo strumento su cui gli uomini si sono accordati per facilitare lo scambio di una merce con un’altra. Non è una delle ruote del commercio: è l’olio che facilita e rende più scorrevole il movimento delle ruote.” – David Hume. Con questa citazione Hume osserva che il denaro è solo uno strumento di natura convenzionale atto ad agevolare e velocizzare gli scambi. In realtà, infatti, quando paghiamo un prodotto con le nostre banconote, stiamo pur sempre scambiando lavoro per 61 lavoro, merce per merce. Fino all’inizio del Novecento la moneta era costituita da metalli preziosi. Il denaro è assai pratico ed efficiente perché adempie a tre funzioni diverse*: 1) Mezzo di scambio: il denaro è più pratico da trasportare rispetto alla merce normale ed è un bene neutro che garantisce intercambiabilità diretta, essendo accettato da tutti; nel caso dei baratti, invece, è più difficile ottenere immediatamente quello che ci serve, poiché è necessaria una coincidenza di desideri reciproca (es. se voglio scambiare un sassofono con un telescopio, è necessario che la persona che possiede il telescopio desideri a sua volta il mio sassofono). Va sottolineato che la moneta, in quanto mezzo di scambio, deve essere resistente all’usura e non deve essere facile oggetto di contraffazione (altrimenti nessuno si fiderebbe ad accettare monete in cambio della propria merce). 2) Riserva di valore: significa che il valore del denaro non cambia nel tempo, perciò posso accumulare moneta in previsione di scambi, acquisti e transazioni futuri. 3) Unità di conto: il denaro ci permette di capire facilmente quanto vale una certa merce e di confrontare più prodotti osservando la differenza tra i prezzi. In questo modo riusciamo a gestire il nostro budget. *Fu William Jevons a definire queste proprietà del denaro nel 1855. Il motivo per cui è stato scelto proprio l’oro tra tutti i metalli preziosi è che esso è anzitutto una risorsa scarsa da sempre (nel senso che non ce n’è molto a disposizione); inoltre, l’oro è duttile e può essere impiegato per realizzare gioielli, può essere fuso e riutilizzato, ed è facilmente scomponibile in unità di misura più piccole. Infine, l’oro non arrugginisce. CREDITO E ASSICURAZIONE Credito e assicurazione potrebbero essere nati prima del denaro, in quanto non presumono l’utilizzo di denaro fisico: in base al meccanismo del credito, il risparmiatore che ha un surplus di reddito decide di cedere parte dei suoi risparmi a un intermediario, che a sua volta lo cederà a un imprenditore. In questo modo il risparmiatore rinuncia temporaneamente al suo potere d’acquisto affinché in futuro gli venga restituito con gli interessi. Dati certi prezzi di mercato in un determinato momento, il potere d’acquisto corrisponde alla quantità di merci che è possibile acquistare con una determinata quantità di moneta a disposizione. Dunque, il credito porta un doppio beneficio: il risparmiatore, come già detto, si inserisce nell’ottica di poter soddisfare sia i bisogni immediati sia quelli futuri, grazie al surplus che verrà restituito con gli interessi. L’imprenditore, grazie al prestito, potrà anch’egli soddisfare i bisogni immediati, ma potrà anche creare un reddito futuro, determinando benefici per l’intera società. Il funzionamento del credito dipende dall’esistenza di due fattori: un intermediario e un mercato libero in cui si possano autoregolamentare la domanda e l’offerta. Occorre che quest’ultimo sia gestito da privati (altrimenti sarebbe troppo complesso da un punto di vista burocratico), ma supervisionato da organi pubblici, che garantiscano la legalità delle varie transazioni. Quanto all’intermediario, esso è una banca che colma le asimmetrie informative: il risparmiatore non può essere a conoscenza delle disponibilità economiche e finanziarie della persona a 62 cui cederà il denaro, oppure di quali imprenditori sarebbero disposti a stipulare un mutuo, quindi l’intermediario fungerà da punto di contatto tra i due, dopo aver analizzato Le rispettive affidabilità economico-finanziarie; il tutto a cambio di un compenso. L’assicurazione implica che un soggetto si assicura con una compagnia assicurativa nell’eventualità di subire un danno. A differenza del credito, l’assicurazione presuppone un contatto diretto tra il risparmiatore e la compagnia, senza un intermediario; di conseguenza, è una soluzione che genera più fiducia, perché il risparmiatore decide direttamente a chi cedere il proprio denaro, senza che nessuno lo gestisca al suo posto. La nascita del denaro ha comportato un’autentica rivoluzione mentale: per la prima volta, il risparmiatore aveva la possibilità di prolungare nel tempo il proprio potere d’acquisto, in modo da soddisfare i suoi bisogni futuri. Ci sono due teorie contrapposte riguardo all’origine del denaro: secondo alcuni, esso è nato in maniera spontanea, mentre altri ritengono che sia stato imposto dall’alto, ovvero dai sovrani, che volevano spingere i sudditi a scambiare merci tra loro. A supporto di quest’ultima posizione, nel Settecento l’abate Ferdinando Galiani immaginava una società comunista dove tutti i lavoratori depositavano parte dei beni che avevano guadagnato in una sorta di magazzino, prelevando in cambio il bene di cui avevano bisogno. Ovviamente gli scambi non erano quasi mai proporzionali (es. deposito un chicco di riso e prendo una pagnotta), perciò furono ideati dei registri per garantire un congruo rapporto di scambio: era la nascita dei cambi fissi, che non dipendevano più dalle necessità del singolo cittadino (è l’equivalente a dare un determinato potere d’acquisto a un bene). Questo sistema immaginario è simile all’attuale compravendita dei bitcoin*, gestita da una serie di algoritmi che analizzano le varie transazioni effettuate (es. se devo comprare un tavolo, un algoritmo certificherà che una determinata somma di bitcoin equivarrà al valore di quel tavolo). *I bitcoin, come anche le altre valute virtuali, non vengono fabbricati da un ente pubblico che persegue il fine di mantenere l’equilibrio tra il denaro in circolazione e il commercio di beni e servizi, in accordo con i bisogni dell’economia di un Paese. Vengono invece immessi sul mercato in quantità arbitrarie e fisse. L’oro è il metallo prezioso da sempre usato per la compravendita, in quanto è un metallo duttile, sfruttabile per usi di gioielleria, incorruttibile (= difficilmente alterabile dal tempo; più è puro, meno arrugginisce) e scarso (140mila tonnellate presenti nel mondo, perciò la sua domanda è elevata). Di tutto l’oro estratto al mondo, solo 1/6 viene usato in ambito industriale, mentre il resto viene impiegato in gioielleria o nella tesaurizzazione esplicita, ossia l’accumulo e la conservazione di risorse auree da parte di una persona o di uno stato sotto forma di lingotti o monete preziose, affinché il loro valore venga mantenuto nel tempo (es. riserve auree delle banche). NB: anche la gioielleria ha una funzione di tesaurizzazione, ma non esplicita (perché non è la prima ragione per cui un gioiello viene comprato): va infatti ricordato che, in caso di difficoltà economiche, un gioiello può sempre essere venduto in cambio di un ritorno economico. Per creare tassi di cambio fissi, l’economia e il commercio prevedevano che il quantitativo di oro in circolo nel mercato equivalesse al quantitativo di beni presenti nel mondo; questa correlazione però veniva spesso alterata da eventi quali la scoperta di nuove miniere (più 63 oro sul mercato) o da periodi caratterizzati da livelli elevati di tesaurizzazione (meno oro sul mercato). Solo negli ultimi due secoli è nato il denaro fiduciario, ossia un mezzo di scambio convenzionale che può essere materiale, come le banconote di carta o gli assegni, oppure immateriale, come le scritture contabili o elettroniche, e che di per sé non ha valore intrinseco (= la banconota acquisisce valore solo in base alla fiducia reciproca e alla fiducia che diamo alle banche e agli organi che emettono moneta, ma in sé è un semplice pezzo di carta). Anche il passaggio alla carta moneta comportò una rivoluzione mentale: le persone non erano sicure del fatto che i prodotti materiali sarebbero stati scambiati con un bene che di per sé non aveva alcun valore. La nascita degli stati-nazione fu un evento fondamentale per la diffusione della carta moneta: per nazionalizzare la propria moneta, ogni stato poteva scegliere un regime bimetallico (basato sull’oro e l’argento, es. Francia) o aureo (basato solo sull’oro, es. Inghilterra). Ciò che attribuiva valore alle monete o banconote era il sigillo dello stato che vi veniva apposto, sigillo in virtù del quale chiunque possedesse una banconota poteva andare in banca e chiedere di riceverne l’esatto corrispondente in oro, o viceversa. Per impedire che i governi approfittassero della possibilità di battere moneta, provocando una svalutazione della medesima, tale possibilità divenne esclusiva delle banche*. Qualora infatti fosse stata immessa troppa moneta sul mercato, ci sarebbe stato un periodo di inflazione (= perdita di potere d’acquisto della moneta), mentre una mancanza di moneta avrebbe portato a un periodo di deflazione; in entrambi i casi sarebbe stata alterata la quantità di moneta richiesta per le transazioni. Sotto questo aspetto, la moneta può essere considerata una merce come le altre (perché esiste una domanda e un’offerta di moneta: se l’offerta di moneta aumenta e ne eccede la domanda, aumentano i prezzi nominali, ossia i prezzi stabiliti per convenzione e non sempre corrispondenti alla realtà). *Prima della diffusione delle banconote, i sovrani modificavano la quantità di oro e di argento presente in un dischetto di metallo (i dischetti però erano apparentemente indistinguibili tra loro) in modo tra arricchire le casse dello stato. In tempi più recenti questo rischio inflazionistico andava comunque a vantaggio degli stati, in quanto l’inflazione avvantaggia il debitore, e i più grandi debitori per antonomasia sono da sempre i sovrani (si indebitavano per fare le guerre; inflazionando, ovvero aumentando la quantità di moneta disponibile, riuscivano a ripagare i propri debiti solo formalmente). In Europa il gold standard (= il regime aureo dell’Inghilterra) prevalse fino alla Seconda Guerra Mondiale; durante Bretton Woods (1944) gli USA, in quanto vincitori e nuova superpotenza mondiale, decisero infatti di ancorare l’oro al dollaro e di ancorare a quest’ultimo tutte le altre valute, affinché queste potessero avere tassi di cambio più fissi. Nel 1971 anche questo sistema crollò e le valute rimasero slegate le une dalle altre, con i tassi di cambio che dipendevano dalle oscillazioni di mercato. Nonostante questi avvenimenti, il mercato dell’oro è sopravvissuto e si è ripreso: per esempio, in occasione della nascita della Banca Centrale Europea (1998), le banche nazionali dei paesi membri vi trasferirono parte delle loro risorse auree (non fisicamente, solo formalmente). Nel 1999 fu stipulato il Patto sull’oro delle Banche centrali in seguito a una manovra inglese che si rivelò fallimentare: per diversificare le proprie risorse economiche, gli inglesi avevano 64 deciso di immettere un grande quantitativo di oro sul mercato, determinandone però un crollo drastico del prezzo. Per impedire che questa situazione potesse ripetersi, le banche centrali dei Paesi europei posero una serie di limiti sull’oro che poteva essere immesso sul mercato, aggiungendo che gli stati firmatari dovevano comunicare tempestivamente a tutti gli altri una loro eventuale intenzione di vendere parte delle loro riserve auree. Oggi il mercato dell’oro è diviso in fisico e virtuale. Il primo si trova a Londra, rappresenta il cuore della compravendita fisica mondiale di oro e argento, ed è governato dalla London Bullion Market Association (LBMA), un’organizzazione fondata dalla Banca d’Inghilterra che stabilisce due volte al giorno il prezzo dell’oro e ha definito nel tempo le caratteristiche che devono avere i lingotti destinati alla tesaurizzazione; la saggiatura preventiva dei lingotti effettuata dalla LBMA permette la good delivery, ovvero la possibilità per i compratori di commerciare oro più liberamente senza doversi sottoporre a tutti i controlli. Per quanto riguarda il mercato virtuale, esso si basa sull’utilizzo di criptovalute come gli ETF, ossia titoli di proprietà virtuali che non possono essere scambiati con oro fisico (solo con banconote) e permettono ai risparmiatori di acquistare quote di proprietà di oro posseduto da altre persone (in questo modo, chi possiede gli ETF ha la garanzia di avere a disposizione potere d’acquisto materiale anche in futuro). Quando si compra un ETF si fa una scommessa sull’aumento del prezzo dell’oro: il vantaggio dell’ETF è che è uno strumento più liquido (è più probabile che un compro oro sia disposto ad accettare ETF rispetto a oggetti o monete di valore) e più sicuro rispetto ad avere in casa una scorta fisica di lingotti d’oro. In un contesto di crisi finanziaria il valore dell’oro aumenta: infatti, quando temiamo che la valuta locale varrà meno, tendiamo tutti a preferire qualcosa di incorruttibile (l’oro o le criptovalute), essendo certi che nel tempo rimarrà un bene di valore, sopravvivendo al rischio di svalutazione. L’ENIGMA ORO Nel corso del tempo l’oro ha mantenuto una serie di caratteristiche: Simbolismo: in passato l’oro ha rappresentato le divinità (spesso le statue delle divinità sono fatte d’oro), oppure il valore (medaglie d’oro al miglior atleta), o ancora bellezza e sfarzo. Moneta: è una merce come tante altre, ma con un valore più elevato e più intercambiabile e universalmente accettato. Credito: l’oro rappresenta l’idea del credito e della restituzione con gli interessi. Fiducia: chi possiede oro ha la certezza che in futuro potrà sempre ottenere quello di cui avrà bisogno in cambio dell’oro stesso. Nel momento in cui tale fiducia nell’oro venisse meno, l’oro perderebbe il proprio valore. L’oro può essere utilizzato in diversi modi: i risparmiatori possono depositare l’oro di cui dispongono in una banca; in questo caso, a differenza degli investimenti in denaro, i risparmiatori non accumuleranno interessi, ma avranno comunque un’assicurazione in momenti di crisi: mentre il valore delle altre valute crollerà, quello dell’oro rimarrà più o meno stabile. Per quanto riguarda le banche centrali nazionali, ognuna conserva una determinata riserva aurea per mantenere la fiducia dei cittadini nel sistema finanziario (questo è un po’ l’enigma dell’oro: perché la nostra fiducia nei suoi confronti è rimasta invariata nel corso dei secoli? E perché l’oro continua a essere oggetto di tesaurizzazione e 65 a essere considerato un bene rifugio per tempi cupi futuri nonostante le scarse possibilità di utilizzo a livello industriale?*). Ovviamente le banche centrali conservano anche denaro e valute nelle loro casse, che possono produrre a loro piacere, a differenza dell’oro. *L’oro, di fatto, è l’ultima risorsa a cui si ricorre per sopravvivere; non c’è un solo Paese che non detenga riserve auree. L’oro può essere utilizzato come pegno: per esempio, nel 1973 i paesi arabi avevano aumentato drasticamente il prezzo del petrolio, il che aveva spinto gli stati importatori a contrarre dei debiti significativi per ottenerlo. Molti paesi, pertanto, avevano pensato di usare le riserve auree sotterranee delle loro banche centrali per finanziare i propri debiti: i rappresentanti della CEE si erano riuniti nei Paesi Bassi per discutere di questa opzione, permettendo infine agli stati di utilizzare le loro riserve auree nel momento in cui decidevano di dare loro un valore pari a quello di mercato, ovvero quando il prezzo a cui vendevano le loro riserve auree sul mercato non sarebbe più dipeso dal dollaro, bensì dal naturale incontro tra domanda e offerta. Se ne parlò poi a Washington durante l’incontro del G10, in cui si stabilì di applicare questa politica anche a livello globale. A seguito di questa decisione, nel caso dell’Italia, il valore delle riserve auree aumentò notevolmente, passando da 3,5 miliardi di dollari a 12,3 miliardi di dollari. Va notato che nel 1973 l’Italia era più indebitata rispetto ad altri paesi perché, all’inizio del decennio, aveva implementato varie politiche di welfare (sanità, pensioni…), rimandando però il pagamento dei costi relativi alla loro applicazione al 1975. Decise perciò di chiedere alla Germania un prestito di 2 miliardi di dollari, e quest’ultima volle in cambio 1/5 delle riserve auree italiane. In realtà non ci fu mai uno spostamento fisico di queste riserve, e nel 1978 l’Italia riuscì a ripagare questo debito. Il problema fu che a livello internazionale l’Italia iniziò a essere concepita come un paese così allo stremo da essere costretto a vendere le proprie risorse auree pur di barcamenarsi nella situazione di crisi che stava vivendo. E questo è proprio il rischio che si troverebbe ad affrontare ogni Paese qualora decidesse di immettere tutte le sue riserve auree sul mercato. Viene da chiedersi allora qual è il motivo per cui i Paesi conservano così tanto oro sottoterra. Del resto, se l’Italia vendesse tutto l’oro di cui dispone la Banca Centrale, riverserebbe sul mercato più della metà di tutto l’oro che viene già commerciato; di conseguenza, l’offerta di oro crescerebbe esponenzialmente e, allo stesso tempo, i prezzi crollerebbero. Ci fu un altro caso storico a sfavore di questa ipotesi: dopo l’armistizio dell’Italia dell’8 settembre 1943, Roma fu occupata dai militari nazisti, che aspiravano a impadronirsi delle 120 tonnellate d’oro della Banca d’Italia, in modo da poterle poi rivendere sul mercato pubblico libero che si teneva in Svizzera per finanziare la guerra che stavano perdendo. Il governatore della Banca d’Italia ideò un inganno nei confronti dei tedeschi: al loro arrivo, i banchieri dovevano dire loro che le riserve auree erano state trasferite a Potenza, poiché girava la voce che la città a breve sarebbe stata conquistata dagli alleati (furono anche prodotti documenti falsi per attestare questo trasferimento). In realtà, l’oro fu nascosto nell’intercapedine vuota che circonda il caveau sotterraneo in cemento armato della Banca, dove è tuttora conservato. Alla fine i nazisti scoprirono che in realtà Potenza non sarebbe caduta in mano agli alleati, perciò il governatore si ritrovò costretto a smontare l’inganno e riportare l’oro nel caveau, arrendendosi. Dopo essersi appropriati delle riserve auree italiane, i nazisti provarono a venderle, ma di quelle 120 66 tonnellate solo 25 furono vendute, mentre le altre 95 furono in seguito recuperate dagli Americani e restituite ai Paesi proprietari. Tale avvenimento testimonia che l’oro è una riserva di valore e può essere accumulato infinitamente, ma se si cerca di venderlo in grandi quantità (tonnellate), l’aumento di offerta che ne deriva fa crollare il suo valore e, ovviamente, il suo prezzo di mercato. Questo è il motivo per cui i nazisti non riuscirono a trovare acquirenti: se un qualsiasi stato avesse acquistato simultaneamente tutte le 120 tonnellate di oro italiano, il valore di quest’ultimo sarebbe diminuito notevolmente, quindi l’acquirente ci avrebbe perso. Un’altra ipotesi è quella di vendere l’oro in maniera graduale, ma se l’Italia lo facesse oggi, il denaro guadagnato non basterebbe comunque a ripagare tutti i debiti. E, soprattutto, ne soffrirebbe la sua reputazione internazionale, con il risultato che gli investimenti provenienti dall’estero crollerebbero a loro volta, vanificando così tutti gli sforzi fatti per ripagare il debito. Anche qualora tutte le banche nazionali del mondo si mettessero d’accordo e vendessero tutto l’oro di cui dispongono, l’offerta sarebbe troppo ampia rispetto al passato e l’oro perderebbe valore in quanto bene rifugio. È dunque difficile liberarsi dell’oro facendolo fruttare (= trasformandolo in denaro corrente). Si può solo sperare che la fiducia collettiva continui a reggere questa convenzione secondo cui l’oro vale molto (in realtà il suo valore dipende dal giudizio e dall’immaginazione di tutti gli esseri umani). Ma quindi l’oro può essere solo conservato sottoterra? Non si potrebbe usare per altri scopi (es. costruire edifici oppure ripagare il debito italiano)? La risposta è no: è impossibile vendere un grande quantitativo di oro; l’Italia ne possiede 2500 tonnellate, che valgono tra 80 e 90 miliardi di euro, a seconda delle oscillazioni del prezzo di mercato; se però le immettesse tutte simultaneamente sul mercato, il prezzo di mercato scenderebbe a 10 o 5 miliardi. SEMINARIO MCCLOSKEY Secondo McCloskey la forza dell’economia e di qualsiasi disciplina risiede nella sua capacità predittiva, che a sua volta dipende dai modelli adottati. Uno dei temi fondamentali dei suoi studi è stato il “grande fatto” della crescita economica moderna, responsabile del passaggio da un contesto storico caratterizzato da guerre e carestie e, più in generale, da lievi miglioramenti e peggioramenti, a un periodo in cui il PIL di certi paesi cresceva del 45% ogni anno. La rivoluzione industriale costituisce uno dei motivi principali che hanno determinato tale fenomeno, difatti la crescita economica moderna non esisteva prima dell’Ottocento, mentre questi ultimi 200 anni hanno visto la diffusione dell’alfabetizzazione e un aumento dal 30% al 100% del reddito pro capite delle persone ordinarie. McCloskey ha anche cercato di dimostrare che esiste una razionalità economica pure nell’agricoltura degli open fields: in altre parole, secondo la sua tesi quest’ultima non era un’agricoltura collettivizzata, bensì presentava caratteristiche simili a quella delle enclosures. Due ulteriori temi dei suoi studi sono stati l’abuso della statistica e la presenza della retorica nell’economia, che, va ricordato, è una scienza, poiché applica il metodo scientifico e cerca di quantificare il proprio oggetto di studio, tentando di prevedere e spiegare la realtà concreta. Al pari di qualsiasi altro scienziato, gli economisti argomentano 67 e fanno delle dimostrazioni, avvalendosi però di figure retoriche, ossia utilizzando il linguaggio in forma non denotativa: ad esempio, in ambito economico la parola “mercato” è una metafora usata per riferirsi alla totalità dei consumatori e dei produttori di un certo bene; “lotta di classe” è un’altra figura retorica che indica le tensioni tra gruppi di persone differenziati dai rispettivi redditi, e così via. Ne deriva che un’analisi anche di tipo letterario è utile per capire i testi degli economisti, anche perché l’economia presenta alcuni tratti della conversazione orale, a partire dalla persuasione (= la capacità di convincere gli altri della validità del proprio punto di vista). McCloskey ha calcolato che circa il 25% del PIL di ogni stato deriva da lavori in cui la persuasione è fondamentale, ad esempio l’avvocato oppure l’imprenditore (che deve convincere altre persone a lavorare per lui). La buona economia, dunque, non è pura analisi. Del resto, anche i dati numerici che troviamo nei grafici (e che potrebbero farci pensare il contrario) derivano da una scelta soggettiva e hanno anch’essi l’obiettivo implicito di persuadere: d’altronde, l’interesse di uno studioso nei confronti di un aspetto specifico di un fenomeno piuttosto che di un altro, come anche le domande che si pone durante la sua ricerca, rivelano implicitamente il suo punto di vista. Possiamo considerare come esempio la legge della domanda, in base a cui la curva della domanda scende nel momento in cui si alzano i prezzi: secondo McCloskey, la scienza economica contemporanea tenta costantemente di dimostrare che ci sono eccezioni a questa legge, ma se chiedessimo agli economisti perché credono che la legge in questione sia vera, otterremmo risposte diverse tra loro, come l’introspezione (= l’esame di coscienza che ogni individuo fa quando aumentano i prezzi, chiedendosi se effettivamente gli serva quel prodotto), oppure gli studi passati, o ancora i risultati statistici di esperimenti concreti da cui è emersa la stessa regolarità. Malgrado solo questi ultimi possano essere dimostrati, le altre risposte non sono prive di validità scientifica. Già nel 1975 Feyerabend scrisse un libro, Contro il metodo, in cui sosteneva che non esiste la polizia scientifica, ossia un ente che sanzioni gli scienziati che non seguono rigorosamente il metodo scientifico; in aggiunta, un’ipotesi non è mai confermata per sempre, ma potrà continuamente essere falsificata. Gli unici risultati accettabili sono quelli in grado di prevedere e spiegare correttamente il funzionamento della realtà; il metodo utilizzato per arrivarci è irrilevante. McCloskey ha applicato questo principio all’economia: storicamente c’è sempre stata la tendenza ad adattare le scienze sociali, come pure l’economia, al modello matematico, rinchiudendo così i comportamenti umani in modelli assai semplici e dotati di una forte capacità predittiva. Tuttavia, con questo atteggiamento si rischia di ridurre l’economia a uno studio della storia del comportamento umano. McCloskey, invece, ritiene che sia importantissimo misurare le cose, ponendosi ogni volta la domanda “Quanto?” (es. per stabilire se il jobs act ha funzionato, un buon economista dovrebbe chiedersi: “quanta occupazione ha creato?”). I problemi insorgono quando si trascura questa domanda (è il difetto di molti economisti attuali, che preferiscono concentrarsi su aspetti poco rilevanti nell’ambito della crescita e dello sviluppo), oppure quando si passa dalla descrizione quantitativa di un fenomeno all’identificazione delle sue cause. In quanto esseri umani, infatti, noi tendiamo sempre a preferire nessi causali meccanici e lineari, ma l’economia è un sistema complesso, con relazioni causa-effetto molto aggrovigliate e non immediate: pertanto, di fronte a un fenomeno economico provocato da diverse ragioni, come la crisi del 2008, gli economisti dovrebbero fermarsi e 68 riflettere su quanto pesa ogni singola causa, in modo da individuare le situazioni più urgenti da risolvere. Secondo McCloskey, però, ciò non avviene; al contrario, gli studiosi di questa disciplina dimostrano troppo spesso un atteggiamento scientista*, formulando previsioni basate su dati scorretti nel loro tentativo di comprendere la realtà: spesso, infatti, per descrivere la società gli economisti assumono come “dati generali” modelli basati su informazioni limitate o variabili (es. le preferenze dei consumatori). Il risultato è una rappresentazione stilizzata, e non puntuale e omnicomprensiva, della realtà (perché i modelli servono solo per comprendere un fenomeno isolato, ma non funzionano nel caso di fenomeni complessi determinati da più cause). *Lo scientismo è un’applicazione meccanicistica e acritica di certi modelli di pensiero ad ambiti diversi da quelli in cui si sono formati; l’esempio classico è l’utilizzo, da parte degli economisti o dei sociologi, del modello deterministico di natura ingegneristica per descrivere i comportamenti umani. Ne deriva che le previsioni che possiamo fare con un grado di certezza hanno tutte un carattere molto generale. Secondo McCloskey, dunque, la scienza è una ricerca approfondita e continuativa, mentre lo scientismo è viziato dall’identificazione di relazioni causa-effetto eccessivamente semplici e basate sulla padronanza di un numero limitato di dati. In aggiunta, per giudicare se certe informazioni sono scientifiche e attendibili bisogna partecipare in forma attiva all’ambito di riferimento (= essere degli esperti, o comunque degli intenditori, di quell’ambito). In molte lingue la parola “scienza” rimanda a un’indagine sistematica di un singolo aspetto della realtà, ma in inglese, a partire dalla metà dell’Ottocento, il termine “science” fu esteso oltre l’ambito della fisica (basata sui modelli matematici e le metafore), includendo anche quello della biologia (basata su un resoconto in forma narrativa e discorsiva dei fatti). Negli USA, dopo la Seconda guerra mondiale, l’economia ha adottato i metodi propri della fisica, diventando comportamentistica e concependo i suoi soggetti (venditori e acquirenti) come degli ingranaggi; in altre parole, si è incentrata unicamente sui loro comportamenti, a prescindere dalle loro motivazioni e dai loro pensieri. Questa tendenza a imitare il metodo della fisica è detta scientismo, e gli economisti che lo adottano si aspettano che tutti i comportamenti degli uomini siano prevedibili, al pari dei fenomeni meteorologici: dopotutto, la meteorologia è fisica applicata. Se l’economia funzionasse come la fisica tutti gli economisti o gli investitori sarebbero ricchi, ma la realtà non è sempre così, in quanto gli esseri umani, a differenza delle molecole, ma anche delle piante e degli animali, hanno un’etica e possono prendere decisioni audaci o prudenti: in poche parole, essi agiscono, non si limitano a reagire, e ciò li rende imprevedibili. L’economia attuale ha diversi vizi: anzitutto, la maggior parte degli economisti concepisce la matematica come una scienza esclusivamente quantitativa e astratta, al pari della matematica utilizzata dagli ingegneri, dai meteorologi o dai fisici (in pratica, pretendono di ridurre e di prevedere la realtà tramite una serie di modelli e di grafici, cosa che funzionerebbe solo nel caso volessimo studiare la storia dell’economia passata). In realtà, però, la matematica economica dovrebbe occuparsi soprattutto di stabilire se qualcosa esiste concretamente o meno, non solo di rispondere alla domanda “quanto?”. Il secondo vizio è di tipo statistico (statistical significance): gli economisti sostengono erroneamente 69 che i numeri contengano intrinsecamente la propria interpretazione, nel senso che se consideriamo una serie di dati (es. i prezzi dei gelati), possiamo stabilire se sono statisticamente significativi e scientifici semplicemente basandoci sui numeri che li compongono (lo stesso vale con le parole: la parola “certo” può anche essere usata in senso ironico). Il problema, però, non è “torturare i numeri” perché ci dicano qualcosa: il problema è scegliere i numeri da “torturare”! Per riassumere, la scienza non riguarda tanto una verità universale e assoluta, quanto quello che gli esseri umani possono dire con certezza sul mondo. 70